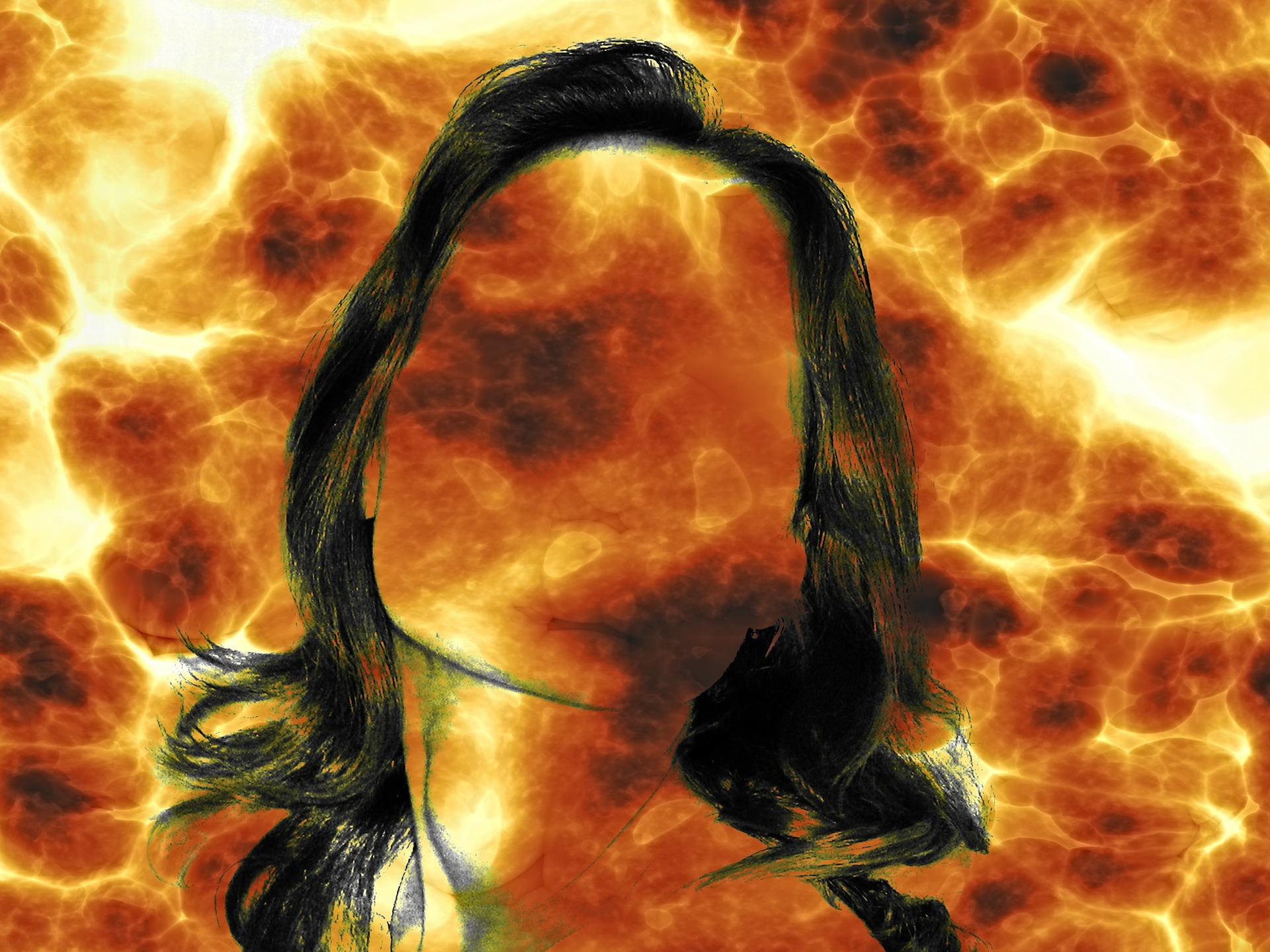Il diritto allo studio e l’inclusione scolastica
|
|
Quando si parla di inclusione scolastica è bene tenere presente che la ricerca nel campo è molto fertile e comporta innanzitutto una riflessione sui termini specifici con cui il linguaggio della scuola definisce la questione. In questo senso, le due parole centrali sono “normalità” e “specialità”. Cosa è “normale” e cosa è “speciale” all’interno dell’aula scolastica? Come spiega Dario Ianes, docente di pedagogia speciale presso l’Università di Bolzano,
Per normalità intendiamo la scuola di tutti, il programma di tutti, la partecipazione, l’essere con gli altri, il valore di sentirsi immersi nel flusso.
Essere “speciali”, invece, significa avere un “funzionamento fragile, difficile o addirittura problematico”. Non è necessario che questa fragilità sia certificata o addirittura disciplinata da una legge, come avviene con gli studenti che beneficiano della legge 104, in quanto essere speciali significa avere dei bisogni educativi diversi rispetto agli alunni il cui sviluppo cognitivo e il cui retroterra rientrano nei parametri della norma a cui fanno riferimento le programmazioni scolastiche.
Questa premessa è fondamentale, poiché il discorso pubblico sui bisogni educativi speciali (BES) ha recentemente preso una piega piuttosto inquietante. Di fatto, sempre più spesso c’è chi suggerisce che le classi dei diversi ordini e gradi della scuola pubblica sono affollate di alunni con disabilità e disturbi dell’apprendimento, e che questo eccesso di inclusione, a cui corrisponde una carenza di insegnanti di sostegno, vada a detrimento dell’istruzione curricolare degli studenti normodotati.
Si tratta di un discorso più strisciante che esplicito, anche se non mancano casi di cronaca che evidenziano il problema. All’inizio di questo anno scolastico in una scuola primaria di Bari, ben quattro famiglie hanno chiesto di trasferire i figli in un’altra classe perché infastiditi dalla presenza di alunni non italiani. La scelta della scuola secondaria di secondo grado è in generale influenzata dal reddito e dall’appartenenza di classe sociale e un elemento determinante nella scelta è dato dal numero di disabili. Nella capitale si registra il caso di quattro alunni con disabilità rifiutati da diversi istituti, per lo più tecnici e professionali, con la motivazione della mancanza di posto.
Il caso ha suscitato un’interrogazione parlamentare a cui è seguita un’ispezione del ministero. Si tratta di casi isolati, che tuttavia rappresentano un termometro del rapporto conflittuale che la società intrattiene con il tema dell’inclusione scolastica. A questi fatti di cronaca si sommano articoli che gettano benzina sul fuoco, con affermazioni la cui rilevanza sul piano delle prassi scolastiche è irrilevante e che, nonostante ciò, lasciano emergere diverse incomprensioni sul modo in cui è trattata la disabilità nel sistema scolastico italiano e su cosa si intenda con i termini inclusione e normalità.
“Quando si sbaglia è giusto ammetterlo”, sostiene Ernesto Galli della Loggia in un articolo dal titolo Il dibattito sulla scuola e la sfida dell’inclusione pubblicato sul Corriere della Sera lo scorso 20 gennaio. L’ammissione riguarda alcune affermazioni contenute in un articolo apparso sullo stesso quotidiano il 13 gennaio, in cui l’autore parlava del saggio di Giorgio Ragazzini (Una scuola esigente. Educazione, istruzione, senso civico, Rubbettino, 2023), insegnante del Gruppo di Firenze, ovvero un movimento di insegnanti che auspica una “scuola del merito e della responsabilità”.
Al di là delle affermazioni offensive nei confronti di una larga parte della popolazione scolastica, in particolare verso gli insegnanti di sostegno, l’intento esplicitato dallo stesso Galli della Loggia era di “sollevare il velo di retorica che solitamente ricopre il principio d’inclusione così come è praticato nella nostra scuola, attirando l’attenzione sui suoi numerosi aspetti critici”.
Nobile proposito senz’altro, tanto più che i massimi esperti in didattica inclusiva si interrogano da anni sulle falle di un sistema che sulla carta garantisce una scuola inclusiva, ma che in realtà è reso macchinoso da una eccessiva burocratizzazione della disabilità e dei disturbi dell’apprendimento, e – questione non secondaria – dalle pressanti richieste di certificazioni da parte sia delle famiglie sia della scuola. Questo carico burocratico incide in modo significativo sulla vita dell’ecosistema scuola, e in effetti si tratta di un problema che è al centro della riflessione proprio di Dario Ianes e dei molti esperti in pedagogie speciali che si occupano di inclusione. Poiché quindi in Italia il dibattito sulla definizione di inclusione è vivace all’interno della disciplina accademica che se ne occupa – ovvero la pedagogia speciale – fa particolarmente impressione leggere le parole di Galli della Loggia:
Inclusione, per chi non lo sapesse, significa la presenza nella medesima classe, accanto agli altri allievi, dei cosiddetti allievi con BES (sta per Bisogni Educativi Speciali): una vasta categoria che comprende i disabili con disabilità lieve media o grave: ad esempio, dai soggetti affetti in vario grado da dislessia o disgrafia medicalmente certificata a quelli con forme di pronunciata disabilità sensoriale o intellettiva; nonché gli allievi di origine straniera non parlanti la nostra lingua.
In realtà, i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), come dislessia, discalculia e disgrafia sono condizioni legate ai tempi e ai modi dell’apprendimento. Pur richiedendo attualmente una certificazione rilasciata da un neuropsichiatra infantile per essere riconosciuti, non implicano l’intervento dell’insegnante di sostegno. Necessitano invece di una serie di accortezze didattiche, che secondo la normativa italiana rientrano nella sfera dei diritti individuali.
Inclusione non significa affatto la presenza nella stessa classe di soggetti con caratteristiche cognitive e fisiche diverse, ma significa adottare strategie didattiche inclusive a livello di consiglio di classe, sia che i soggetti coinvolti stiano seduti nella stessa classe, sia che facciano lezione in altri luoghi, ad esempio, come spesso accade, nelle aule di sostegno attrezzate per le didattiche speciali, delle quali qualsiasi istituto scolastico italiano è dotato. Vi sono infatti condizioni di particolare gravità che richiedono un maggiore raccoglimento, e quindi uno spazio dedicato in cui l’insegnante di sostegno possa concentrarsi sulla particolare criticità di cui si occupa. Inoltre, come spiega Ianes nella già citata intervista, “parlare di inclusione vuol dire parlare di tutte e tutti, compreso chi ha una iperdotazione intellettiva, un background migratorio, una situazione familiare particolare, insomma tutta l’infinita varietà delle differenze umane, questo è lo slittamento di paradigma. Chiaramente questo vuol dire coinvolgere tutti gli insegnanti, e non solo quelli del sostegno”.
Quando il neuropsichiatra infantile, a cui vengono riferiti i bambini che manifestano difficoltà in ambito scolastico, decide che è necessario redigere una diagnosi e quindi rilasciare una certificazione, lo fa perché vengano attivate dalla scuola tutte le misure dispensative e compensative necessarie di modo che si realizzi un’inclusione autentica, la quale passa per le prassi didattiche e non per lo spazio fisico in cui esse vengono praticate. Come spiegato da Ianes, a mettere in atto queste prassi non è il solo insegnante di sostegno quando si prende cura dell’alunno con disabilità, ma tutto il consiglio di classe, accertandosi che ogni alunno che rientra in una casistica di disturbi e condizioni speciali venga raggiunto da una didattica che tenga conto di tutti.
Va inoltre chiarito che l’obiettivo della normativa sull’inclusione scolastica in Italia è soprattutto quello di non discriminare i disabili, ma in generale è anche di impedire che il diritto allo studio venga negato a soggetti particolarmente fragili. Un percorso normativo che dal 1971 a oggi ha caratterizzato la scuola italiana come la più inclusiva al mondo, per quanto si tratti di un’inclusione eccessivamente burocratizzata, e nel frattempo la riflessione sul concetto di inclusione si sia evoluta grazie anche al confronto con la pedagogia internazionale.
L’articolo di Galli della Loggia non rappresenta solamente un segnale di inversione di rotta rispetto al lavoro straordinario, per quanto sicuramente perfettibile, messo in atto dalle scuole italiane nel corso di questi decenni. L’ex professore afferma infatti che
Per ogni classe che si trovi in questa condizione è prevista per gli allievi con disabilità Bes la presenza per un massimo di 18 ore settimanali — il monte ore di lavoro standard nella scuola — di un cosiddetto «insegnante di sostegno» (ma 18 ore nella medesima classe sono previste solo se questa ospita un caso molto grave, se no ci si limiterà a un semplice spezzone di tale monte ore).
L’aspetto grave di queste affermazioni risiede nel fatto che divulgano su un quotidiano molto letto un’idea di sostegno falsata. Un allievo con una disabilità grave può arrivare, infatti, ad avere l’intero orario curricolare coperto da più insegnanti di sostegno, a seconda della disponibilità della scuola e non certo della gravità della disabilità. Avendo in precedenza confuso disabilità e DSA, l’articolo lascia intendere che sia sufficiente una dislessia perché uno spezzone venga assegnato alla classe.
Forse l’aspetto peggiore di questa pessima divulgazione consiste nella rappresentazione che viene data dell’insegnante di sostegno:
Nella maggioranza dei casi l’insegnante “di sostegno” non ha alcuna preparazione specifica se non alcune vaghe nozioni d’ordine generalissimo apprese in un corso annuale. Che tipo di “sostegno” potrà quindi assicurare se non quello genericissimo di una semplice presenza/assistenza? Ma non solo: sempre nella maggioranza dei casi (ma direi nella grande maggioranza dei casi) gli insegnanti “di sostegno” ambiscono in realtà a lasciare il loro ruolo per inserirsi nel ruolo normale d’insegnamento: ciò che una legge dà loro diritto di chiedere dopo un triennio.
Un insegnante di sostegno che legga sul principale quotidiano nazionale una sua caratterizzazione così macchiettistica non può che sentirsi avvilito, visto che in sostanza si dice di questa figura che non solo non sa niente perché nessuno si è preso il disturbo di formarlo, ma come aggravante sta lì solo per tre anni per poter poi accedere al ruolo nella propria classe di concorso.
È compito arduo tentare di convincere chi non ha né volontà né strumenti che il ruolo svolto dall’insegnante di sostegno nel seno della società e non solo nell’ambiente ristretto e spesso asfittico della scuola è fondamentale. Solo i genitori di figli con disabilità possono raccontare le esperienze positive e negative vissute rapportandosi con queste figure, le cui competenze sono certamente molto diseguali e le formazioni molto eterogenee. Si va dai laureati in scienze dell’educazione agli assistenti sociali, che trovano in questo ruolo un habitat naturale e un’applicazione pratica più vicina ai propri studi rispetto ad altre professioni meno coinvolgenti, all’insegnante di religione cattolica che ritiene più significativo occuparsi di sostegno piuttosto che fare lezione a gruppi classe sempre più striminziti e refrattari alla materia.
Ci sono anche gli insegnanti alle prime armi che attendono il ruolo nella propria disciplina e che nel frattempo accettano supplenze sul sostegno. Ma è sufficiente l’eterogeneità dei percorsi di provenienza per svalutare questa figura? Spesso si tratta di persone molto colte che si trovano nella situazione di sviluppare una competenza in più, molto diversa rispetto a quella a cui li consegnerebbe la professione docente esercitata solo nell’ambito della propria classe di concorso. Sull’arricchimento che l’esperienza del sostegno porta all’insegnamento curricolare si discute ampiamente, tanto è vero che è stata presentata pubblicamente la proposta di legge Introduzione della cattedra inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado, redatta e sottoscritta da un gruppo di noti esperti dell’inclusione scolastica (Evelina Chiocca, Paolo Fasce, Fernanda Fazio, Dario Ianes, Raffaele Iosa, Massimo Nutini, Nicola Striano) e prevede che gli insegnanti curricolari svolgano parte del loro orario sul sostegno e viceversa, di modo che i due mondi non rimangano più separati in compartimenti stagni.
Questa proposta di legge non manca di sollevare perplessità nel mondo della scuola: l’idea che il ruolo del sostegno venga svolto anche dai docenti curricolari, rendendo così strutturale una collaborazione che di fatto avviene già, è percepita come un primo passo verso la graduale eliminazione della cattedra di sostegno e il conseguente obbligo di una formazione specifica nelle pedagogie speciali per gli insegnanti curricolari. In realtà, chi si è abilitato ed è entrato in ruolo negli anni più recenti ha già ricevuto quel tipo di formazione. Tuttavia, il dubbio rimane legittimo e l’ipotesi che l’esito di una tale proposta sia di suggerire in qualche modo che si possa fare a meno del sostegno a scuola non è rassicurante. Ianes ha fatto il punto in un articolo dal titolo Cattedra inclusiva: perché mescolare insegnamento curricolare e di sostegno, pubblicato su Domani.
In una società in costante evoluzione, in cui il cammino verso la normalizzazione dei disturbi dell’apprendimento e il dialogo sulla diversità è aperto, visioni che ricordano un cupo passato sono disturbanti e ancora più imbarazzante è che vengano ospitate dai principali quotidiani del paese.