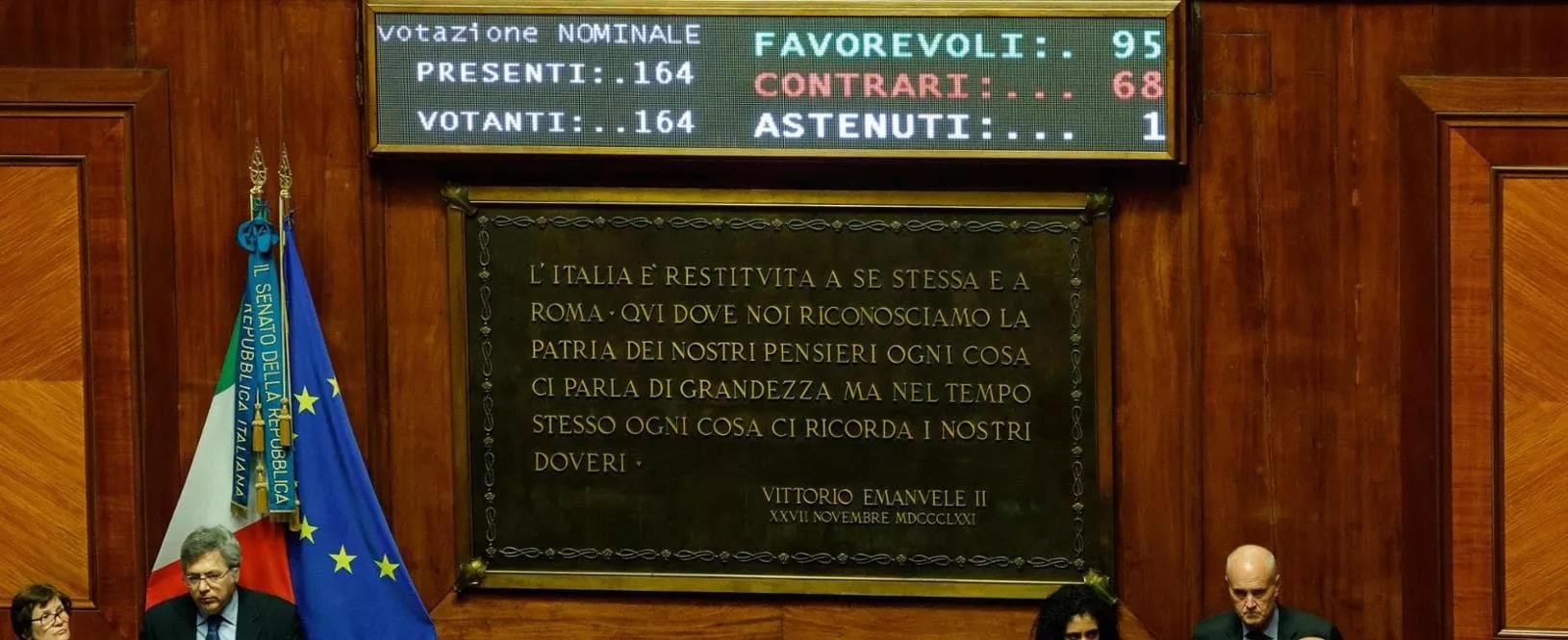Parlare di aborto senza colpa e vergogna
8 min letturaA febbraio di quest’anno il volto e il nome di Alice Merlo, attivista genovese di 27 anni, sono comparsi sui manifesti della campagna dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (UAAR) in favore dell’aborto farmacologico, definito una “una scoperta scientifica meravigliosa per la salute della donna”. Pochi mesi prima, a settembre, Merlo aveva abortito con la RU486 all’ospedale San Martino di Genova e aveva deciso di raccontare su Facebook quello che aveva vissuto utilizzando parole come “serenità” e “gratitudine”.
«La mia esperienza è stata assolutamente positiva», spiega a Valigia Blu, «la ginecologa che mi ha seguita è stata professionale e cristallina, non mi sono scontrata con l’obiezione di coscienza e a differenza della stragrande maggioranza delle persone ne ho potuto parlare serenamente con la mia famiglia, con i miei amici, con il mio datore di lavoro e con i miei colleghi e mai nessuno o nessuna ha giudicato la mia decisione».
Quando a dicembre in varie città – Genova compresa – sono iniziati a comparire dei manifesti promossi dall’associazione contro la libertà di scelta Provita e Famiglia che definivano la RU486 “un veleno”(e alcuni sindaci si sono rifiutati di rimuoverli), Merlo ha deciso che era arrivato il momento di prendere parola pubblicamente. «Non perché non ci fossero già tante persone che stavano protestando contro quei manifesti, ma perché nessuna stava parlando del suo aborto. Mi sono resa conto che io lo facevo nella mia cerchia più stretta, ma c’era bisogno di qualcuno che mettesse la voce e la faccia per dire che l’aborto è un diritto, che la RU486 non è assolutamente un veleno ma un farmaco sicuro e una scoperta scientifica meravigliosa perché davvero aiuta le donne a effettuare l’aborto in sicurezza, in maniera meno invasiva e senza ricorrere a un’operazione chirurgica». Successivamente, è stata contattata dall’UAAR ed è partita la campagna che ha raggiunto circa 80 città italiane.
Visualizza questo post su Instagram
Da quel momento Merlo ha iniziato a ricevere insulti e minacce da parte di gruppi antiabortisti, sia sui social che con scritte sui cartelloni che la ritraevano. A criticare il suo racconto, però, non è stato solo l’universo anti-choice (contro la libertà di scelta), ma anche persone che si dicono favorevoli alla legge 194 ma che non condividono il registro e le parole usate da Merlo per descrivere la sua personale esperienza: serenità, sollievo, scelta felice.
Nonostante siano passati più di 40 anni dalla legge che nel 1978 ha reso l’aborto legale nel nostro paese, l’unica narrazione possibile sull’interruzione volontaria di gravidanza è quella di una scelta necessariamente dolorosa e sofferta per tutte, di un trauma insanabile, di uno spartiacque nella vita di una donna. Un peso da sopportare per poter ammettere di aver avuto accesso a un diritto.
La decisione di interrompere volontariamente una gravidanza (non si sta parlando qui di aborti spontanei) non è però un monolite uguale per tutte le persone: ce ne sono alcune che affrontano l’aborto con grande sofferenza, specialmente quando si tratta di IVG cosiddette terapeutiche, ossia oltre i 90 giorni, che riguardano gravidanze cercate e desiderate. Ce ne sono altre che lo fanno con un altro stato d’animo: non vogliono essere madri, non vogliono esserlo ancora, non vogliono esserlo in quelle particolari circostanze. Ma nel dibattito pubblico non sembra esserci spazio spazio per esperienze diverse - così come dimostra la vicenda di Merlo.
«Credo sia importante parlare del fatto che parte di chi difende la 194 e il diritto alla libertà di scelta delle donne lo fa a certe condizioni, ossia che tu parli del tuo aborto solo in determinati termini: come di un trauma, come di una cosa che per te non è stata facile, come di una cosa sofferta, e come di una colpa. Alla fine sembra che il concetto sia che è colpa tua che sei rimasta incinta», dice Merlo.
Questo tipo di racconto basato sulla necessaria sofferenza è pervasiva nel dibattito mainstream. Nel 2018 in una lettera a Papa Francesco su La27esimaOra, la scrittrice Dacia Maraini scriveva che “nessuna donna ha piacere ad abortire. Se lo fa è perché costretta da tante ragioni dolorose”. Lo scorso febbraio, commentando una dichiarazione antiabortista di Matteo Salvini, Laura Boldrini ha twittato che “decidere di abortire per una donna è una scelta difficile”. A luglio Roberto Saviano, inserendosi nel dibattito sulle limitazione all’interruzione di gravidanza con metodo farmacologico della giunta umbra della presidente Tesei, ha scritto che “l’aborto è un passo doloroso che nessuna donna compie senza averci riflettuto e senza averci sofferto”. Un articolo uscito su Repubblica ad agosto che annunciava le nuove linee di indirizzo del ministero della Salute sulla RU486 definiva quella di interrompere una gravidanza “sempre una scelta dolorosa”.
Il frame della sofferenza si lega allo stigma che circonda l’aborto, che è considerato come una cosa sbagliata, negativa in sé. Lo stesso stigma si estende alle donne che lo affrontano, che a loro volta sono colpevoli di essersi trovate in quella situazione.
«Il discorso dell’aborto come scelta necessariamente dolorosa affonda le sue radici nella necessità di colpevolizzare il vissuto di una donna che sceglie di autodeterminare il proprio corpo, rinnegando in quel momento specifico quella che è un funziona biologica predestinata, cioè la maternità. La frase “sono favorevole all’aborto ma è sempre un’esperienza dolorosa” non fa altro che stigmatizzare la donna che si sta negando la maternità», spiega a Valigia Blu Federica Di Martino, psicologa co-fondatrice della pagina “IVG ho abortito e sto benissimo”, nata nel 2018 con l’obiettivo di offrire una narrazione diversificata sull’aborto rispetto a quella classica e univoca. «Quello che ho fatto è stato offrire uno spazio di parola per riappropriarci delle nostre storie e dei nostri aborti perché ogni aborto è un’esperienza diversa e non può essere ricondotta a un’unica matrice emozionale e narrativa», dice Di Martino.
Visualizza questo post su Instagram
Recentemente anche la campagna "Non è un veleno", nata per contrastare quella di disinformazione sulla RU486 a opera dei gruppi anti-choice, ha aperto uno spazio "Ho abortito e ve lo dico, senza colpa e senza vergogna".
Secondo uno studio accademico pubblicato sul sito della rivista Women’s Health Issues, lo stigma dell’aborto consiste nel discredito di coloro che a questo vengono associate ed è un argomento poco studiato e indagato. La ricerca individua diverse ragioni del perché all’interruzione volontaria di gravidanza sia correlato questo stigma, tra cui proprio quello di violare l’ideale femminile della maternità: “Il desiderio di essere madre è centrale nell’essere una ‘brava donna’. Di conseguenza l’aborto è stigmatizzato perché è la prova che una donna ha avuto rapporti sessuali a scopo non procreativo e sta cercando di esercitare il controllo sulla sua riproduttività e sulla sua sessualità, ed entrambe minacciano le norme di genere esistenti”.
L’aborto è stigmatizzato inoltre dall’attribuire personalità al feto o da restrizioni di vario tipo a livello legislativo. Secondo le ricercatrici, lo stigma è uno strumento potente nelle mani dei gruppi antiabortisti, che provano a erodere il supporto pubblico nei confronti della libera scelta. Ad esempio promuovendo insistentemente l’esistenza della cosiddetta “sindrome post-abortiva”, un disturbo psicologico simile a quello post-traumatico da stress che però non trova fondamento scientifico. Uno studio dell’American Psychological Association ha rilevato che le donne che hanno interrotto volontariamente una gravidanza non pianificata non presentano un maggiore rischio di problemi di salute mentale, ma che semmai le esperienze psicologiche delle donne che hanno abortito sono influenzate dallo stigma sociale, dalla necessità della segretezza, dall’essere esposte alle critiche di gruppi contro la libertà di scelta e dall’avere avuto poco supporto sociale.
«Lo stigma dell’aborto ha una funzione strumentale e politica, perché se io mi devo vergognare di avere abortito e deve essere stata necessariamente un’esperienza dolorosa non posso uscire da quel tracciato narrativo. In secondo luogo, così si silenziano anche le esperienze di violenza che accadono all’interno dei luoghi della salute pubblica, che vengono reiterati ma non vengono raccontati perché considerati automaticamente il processo naturale», afferma Di Martino, che menziona l'alto tasso di obiezione di coscienza in Italia: una media nazionale del 69% e picchi più alti in alcune regioni. L'attivista ricorda la testimonianza di una donna che si era recata in un consultorio per interrompere per la seconda volta una gravidanza. «L’ostetrica le ha detto “il tuo aborto è una vergogna per il nostro lavoro”. Lei me l’ha raccontato e poi mi ha detto che però, in fondo, aveva ragione. Questo è lo stigma sociale che viene interiorizzato dalle donne, che si sentono colpevoli e dunque tutto quello che viene dato loro diventa una grande concessione. Perché i nostro diritti e la nostra autodeterminazione devono essere comunque controllate da un sistema di potere assoggettante. Fuoriuscire da quello significa uscire da quel sistema. Io non voglio ringraziare, perché sono una cittadina che paga le tasse per avere un diritto garantito dalla sanità pubblica. E non devo edulcorare il mio pensiero, non lo devo rendere più digeribile».
Anche secondo Merlo la vergogna e la colpa permettono «a chi eroga il servizio di offrire un disservizio. Perché quando la società ti sta dicendo che la tua paziente è colpevole, tu ti senti un po’ autorizzato a trattarla come tale. Nei reparti di ginecologia non c’è scritto da nessuna parte “ambulatorio IVG”, come se fosse un segreto, una cosa di cui non si deve parlare».
Visualizza questo post su Instagram
A causa dello stigma, la maggior parte delle esperienze che riguardano aborti non vengono raccontate dalle persone direttamente interessate. Come si legge in un articolo pubblicato su Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy, rivista accademica peer-review pubblicata dalla Cambridge University, “le storie che raccontiamo sull’aborto sono spesso raccontate per recuperare moralmente attraverso la tragedia la condizione della donna che abortisce”.
Quando Di Martino ha aperto la pagina non sapeva se qualcuna l’avrebbe mai contattata per lasciare una testimonianza del suo aborto. Invece, «è emersa un’esigenza narrativa che è diventata sempre più forte. Molte storie arrivano anche in seguito a un accompagnamento che facciamo alle donne che devono interrompere una gravidanza. Questo per me è importante perché se una donna nel proprio aborto viene accompagnata e sostenuta e tranquillizzata adeguatamente rispetto alla retorica anti-choice che è dilagante, poi riesce ad abortire e stare benissimo». L’esigenza narrativa di cui parla Di Martino nasce spesso dal fatto che le donne «spesso non hanno raccontato di aver abortito quasi a nessuno, e poi «si rendono conto che c’è una corrente narrativa di autocoscienza rappresentativa e vogliono essere parte di questa possibilità, riscrivendo anche la loro storia. In secondo luogo, vogliono essere di supporto e sostegno ad altre persone, perché quello che mi scrivono sempre è “spero che la mia esperienza possa aiutare qualcun’altra a sentirsi meno sola”».
Lo stigma è infatti direttamente collegato alla solitudine. «Ti senti sola, ti senti l’unica, che stai facendo qualcosa di sbagliato. Quando è altamente improbabile che tu non conosca, non voglia bene o non ami qualcuna che ha abortito. E, come dico sempre, non vorresti meno bene a una donna perché hai saputo che ha abortito», dice Di Martino, che aggiunge che però «tutte o quasi mi chiedono di restare anonime: perché non l’hanno raccontato in famiglia, perché lo sanno poche persone, perché non vogliono sentirsi giudicate dall’esterno».
Come scrive Tania Zaparaniuk su Cosmopolitan, le donne provano vergogna per una procedura di routine e “vengono fatte sentire isolate – anche se una su tre ha un aborto nel corso della vita (…) Alcune donne, come me, scelgono di abortire perché non vogliono ancora avere figli. Altre non li vogliono e basta. Alcune li vorrebbero disperatamente, ma scoprono durante la gravidanza che il feto non sopravviverà. Altre ancora, già madri, sanno che non potrebbero mantenere altri figli. Le decisioni e le esperienze che riguardano l’aborto sono tanto differenti quanto lo sono le donne che decidono di abortire. Ma lo stigma – in varia misura – è qualcosa che tutte abbiamo in comune”.
Sovvertire il racconto stereotipato dell’aborto non vuol dire banalizzare la sofferenza di chi l’ha vissuto come una scelta dolorosa, ma accettare e accogliere una pluralità di narrazioni. «Ogni esperienza di aborto è diversa, perché siamo persone con storie diverse. Possono essercene di più o meno dolorose, ma il dolore per essere rispettato non va imposto. La mia è stata serena e felice e non vedo perché dovrei nascondermi», spiega Merlo. «Capisco che se per anni l’unica narrazione possibile dell’aborto è stata quella del dramma, le persone fanno fatica ad accettarne una differente. Ma a queste persone bisogna chiedere di sospendere il giudizio, mettersi in ascolto e dare spazio alle voci di coloro che hanno effettivamente abortito per raccontare la loro esperienza».
Foto anteprima via Donne Magazine