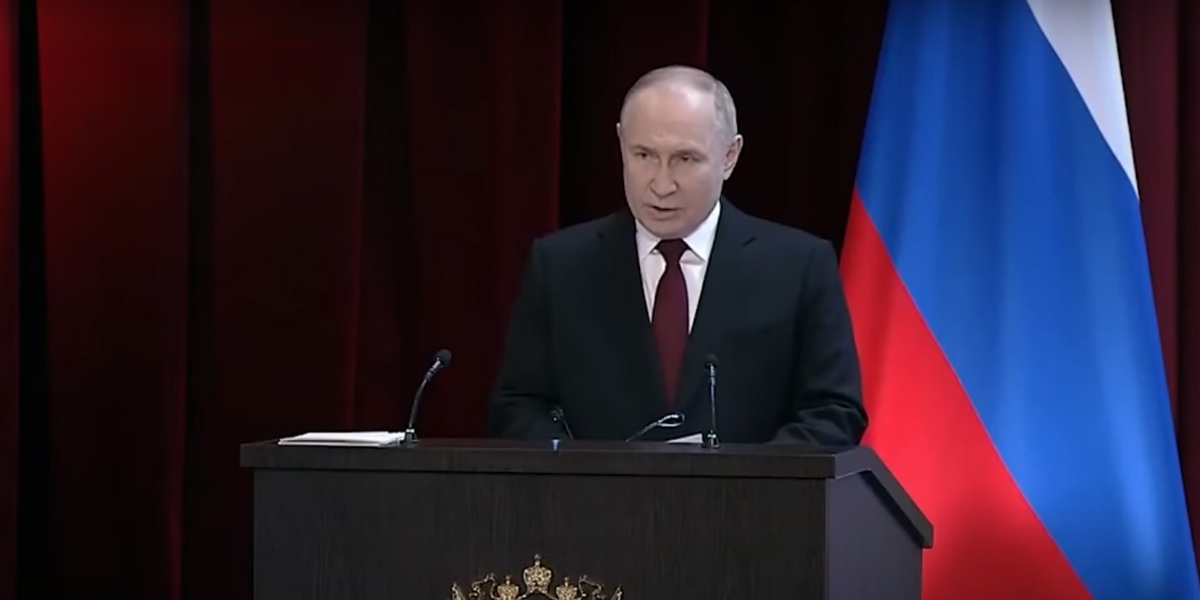Chi è la giornalista che racconta il mondo dei terroristi ISIS tra fonti dirette e social network
14 min letturaHa collaborato Andrea Zitelli
Fin dove può spingersi un giornalista quando si occupa di terrorismo? Quale uso fare delle fonti? Qual è il confine tra fare informazione e fare il gioco dei terroristi quando si raccontano i jihadisti? La storia di Rukmini Callimachi, corrispondente esteri del New York Times, esperta di estremismo islamico e tre volte finalista al premio Pulitzer per i suoi articoli, incontra tutte queste domande.
Il suo percorso giornalistico costringe a confrontarsi con le problematiche che deve affrontare chi, come lei, si occupa di organizzazioni terroristiche: il metodo e l'etica del lavoro, la cura e la verifica delle fonti e la premura della loro riservatezza, la scrittura degli articoli e l'attenzione verso i lettori, il rischio di farsi propaganda delle organizzazioni stesse di cui si vuole parlare.
Nei suoi articoli, Callimachi non cerca di raccontare solo cosa i jihadisti fanno, ma anche come agiscono, per dare ai lettori gli strumenti per comprenderne i loro piani, la loro struttura organizzativa, i loro codici simbolici, il linguaggio utilizzato.
In uno dei suoi ultimi pezzi, How a Secretive Branch of Isis Built a Global Network of Killers, ad esempio, tramite la testimonianza di ex combattente dell'Isis, la giornalista del New York Times mostra come funziona la struttura segreta dello Stato Islamico che recluta, addestra e pianifica attentati nel mondo.
For four years now, I have been speaking to terrorists as part of my beat. Here's the story of our Harry Sarfo intv https://t.co/nvp3fii2SG
— Rukmini Callimachi (@rcallimachi) 9 agosto 2016
Un lavoro costruito incrociando le informazioni ricavate da documenti dell’antiterrorismo francese, belga, tedesco e austriaco con quelle fornite dal proprio testimone e prestando un’attenzione meticolosa alla cura delle fonti, alla verifica delle testimonianze raccolte – in diversi passaggi la giornalista spiega quando le parole dell’intervistato non sono completamente provate e quando invece trovano conferme in quanto documentato da altre fonti, orali o scritte – e alla ricostruzione del contesto.
Ma ancora più interessante è il metodo di lavoro grazie al quale Callimachi riesce ad acquisire contatti e informazioni sulle organizzazioni più ostili e segrete del mondo, coniugando lunghi periodi sul campo alla frequentazione assidua dei social network – usati dai gruppi terroristici per comunicare, organizzarsi e fare proselitismo – per entrare in quello che lei stessa, in una recente intervista su Wired, ha definito il “mondo interiore dei jihadisti”.
Raccontare i jihadisti è fare informazione o il gioco dei terroristi?
Come osi vedere i terroristi come qualcosa di diverso dai cani disgustosi che sono?
Da quando ha iniziato a scrivere sui jihadisti, Rukmini Callimachi è stata spesso criticata per i suoi lavori e ritenuta responsabile di dare voce a chi, mietendo vittime e commettendo atti di terrore, invece, non dovrebbe averne. Le critiche si sono concentrate sul rischio di “umanizzare” i terroristi e di dare loro credibilità, visibilità e contenuti alimentandone la propaganda. Come è successo, ad esempio, per un articolo, pubblicato subito dopo l’attacco alla redazione di Charlie Hebdo, in Francia, che suscitò la reazione polemica del direttore dell’FBI, James Convey.
Nel pezzo, scritto insieme a Eric Schmitt e Mark Mazzetti, Callimachi aveva sottolineato di aver consapevolmente preservato l’anonimità di una sua fonte, vicina ad Al-Qaeda, che aveva smentito che l'attentato fosse opera di un piano comune con l’Isis (ipotesi che aveva cominciato a diffondersi nei giorni immediatamente successivi alla strage), ma frutto di un'amicizia fra Amedy Coulibaly e i fratelli Kouachi.
In una lettera al New York Times, Convey definiva “mistificante e disgustosa” la decisione di concedere l’anonimato a un portavoce di un gruppo terrorista e si diceva preoccupato per le sorti di un giornale pubblico e prestigioso che «si prestava a essere usato da chi lavora ogni giorno per uccidere sempre più persone per poter chiarire il proprio ruolo rispetto a una strage in cui erano morte tante persone innocenti».
Michael Slackman e Margaret Sullivan, rispettivamente International Managing Editor e Public Editor del New York Times (oggi al Washington Post), difesero la scelta della giornalista sostenendo che un giornale fa il proprio dovere quando è al servizio dei lettori e dà loro informazioni utili. «Dare voce a tutte le parti non significa essere portavoce di qualcuno, ma fare informazione», rispose Slackman a Convey. "Si fa un servizio migliore ai lettori se si danno informazioni tempestive, precise e controllate nel modo più completo possibile", scrisse Sullivan in un intenso editoriale:
Il New York Times deve essere straordinariamente attento a utilizzare le informazioni provenienti da un’organizzazione terrorista. Deve dire il più possibile ai lettori come sono state ottenute le informazioni, da dove provengono e come sono state verificate.
L’intera vicenda – l’articolo di Callimachi, la reazione del direttore dell’FBI, le risposte di Slackman e Sullivan – pone al centro la questione dell'uso delle fonti, del confine tra fare informazione e fare il gioco dei terroristi, del ruolo stesso dell'informazione come servizio ai lettori: si fa un servizio ai lettori non dando voce ai terroristi o garantendo la pluralità delle voci - come metodo per affrontare la complessità - e verificando le fonti?
Tutte questioni non limitate all’episodio citato, ma che si ripropongono quasi ogni volta si tenti di coprire un attacco di matrice terrorista.

Riguardo le fonti e il loro uso, Callimachi afferma che i giornalisti stanno percorrendo un territorio ancora tutto da esplorare: «Quando parlo con queste persone, sono consapevole che sto parlando con terroristi. Sono sempre preoccupata e mi chiedo spesso: è giusto che io parli con loro? Ma poi penso che si tratta di temi così delicati e duri che richiedono il ricorso a fonti non convenzionali».
Mentre, rispetto alla questione della visibilità fornita a un gruppo terroristico, la giornalista, in un’intervista su Slate ha sottolineato che anche se un gruppo terroristico come l’Isis, dopo una strage come quella di Orlando, voglia che si parli di sé, al tempo stesso non si può fare finta di niente: «Non credo che non parlarne o non confrontarsi possa essere d’aiuto in alcun modo per la sicurezza nazionale».
Anzi, non affrontare la questione è uno dei motivi che ha portato a non comprendere la nascita e la crescita dello Stato Islamico e a sottovalutare la sua forza e la sua capacità pervasiva anche oltre l’Iraq e la Siria: «Se noi coprissimo Isis nel mondo così come me ne occupo io personalmente, cioè nel mondo in cui mi aggiorno su di loro, nessuno nell’amministrazione statunitense avrebbe mai descritto Isis come JV team».
Callimachi fa qui riferimento a un’espressione utilizzata dall’allora Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che, nel 2014, subito dopo l’attacco a Falluja, descrisse l’Isis come uno JV team, che significa Junior Varsity e viene utilizzato per identificare le squadre di pallacanestro non professioniste, come quelle di college. Obama aveva, dunque, ritenuto lo Stato Islamico la squadra B di Al-Qaeda, che, secondo lui, era stata ormai debellata dopo l’uccisione di Osama Bin Laden.
Raccontare i terroristi, cercare di capire come si organizzano, di cosa parlano, come teorizzando le loro azioni, non significa sminuire o negare i crimini che commettono, prosegue Callimachi, ma è fare il mestiere di giornalista, capire e prestare attenzione alle sfumature dove tutto di solito viene raccontato e visto nettamente distinto in bianco e nero:
Penso che il nostro lavoro di giornalisti sia cercare di comprendere e portare alla luce i grigi laddove c’è solo il bianco e il nero. Perché il grigio c’è sempre.
L’alternativa tra parlare e fare il gioco dei gruppi terroristici e tacere e non essere loro cassa di risonanza, non è, dunque, senza vie d’uscita. La soluzione è nel fare un lavoro giornalistico, nel saper coprire le notizie, nella cura dei particolari, nel cercare materiali grezzi ed elementi che possano poi consentire di unire i puntini (o almeno provare a farlo) e capire quello che sta succedendo.
Rovistare alla ricerca di materiale grezzo e provare a unire i puntini
Uno dei momenti decisivi nella carriera giornalistica di Callimachi è nel 2013, quando torna in Mali, a Timbuktu, dove era stata in passato inviata di The Associated Press, e viene in possesso di documenti importanti della cellula locale di Al-Qaeda, appena sgominata dalle forze francesi.
«Stavamo tutti [i giornalisti] scarpinando per la città cercando storie, alla fine molto simili. Allora ho iniziato a chiedere alle persone del posto se potevano mostrarmi gli edifici utilizzati dal gruppo terroristico», racconta Callimachi a Caitlin Roper su Wired. Le indicano una banca, diventata centro di polizia islamico, un hotel, dove era stata stabilita una corte della Sharia e un ufficio delle tasse, trasformato in ufficio amministrativo jihadista. In ognuno di questi edifici, la giornalista trova numerosi documenti scritti in arabo: «All’inizio ho pensato si trattasse di materiale poco importante, non li avevo nemmeno letti. Il giorno successivo, ripensandoci, ho realizzato che potessero essere documenti lasciati dai jihadisti. Così sono tornata con un mucchio di buste per la spazzatura e, girando edificio per edificio, dieci in tutto, ho raccolto qualsiasi cosa trovassi. Fu così che a Timbuktu mi chiamarono Lady Spazzatura».
Aurora Prize | Rukmini Callimachi from STEREOTACTIC on Vimeo.
In quei documenti, c’era di tutto, da resoconti strategici a dibattiti ideologici sulla teologia.
Quello che erroneamente, in un primo momento, mi sembrava una cosa di poco conto, un gruppo di ragazzi che, chiusi in una grotta, per un motivo sbagliato avevano sposato un’ideologia, in realtà raccontava altro, (…) di un movimento molto più complesso. (…) Il materiale grezzo che il gruppo aveva lasciato era un’inesauribile fonte di storie e, al tempo stesso, oggetto interessante di reportage. Bisognava continuare a scavare alla ricerca di quel materiale.
È in questo momento che Callimachi capisce che ricorrere solo alle fonti ufficiali e di intelligence non era l’approccio più idoneo per riuscire ad avere informazioni e a comprendere cosa stava accadendo e come si stavano ri-organizzando i gruppi terroristici. Il lavoro sul campo le consente di cogliere aspetti che altrimenti le sarebbero sfuggiti. Seguendo gli indizi trovati sul posto, la giornalista si imbatte per la prima volta nell’Isis. I pochi jihadisti con cui era in contatto le raccontano che molti si stavano trasferendo in Siria per unirsi non al Fronte Al Nusra, gruppo locale di Al-Qaeda, ma per affiliarsi allo Stato Islamico e al progetto del califfato. In Siria, l’Isis si era ribellato alla guida di Bin Laden e Zawahiri e aveva scelto una strada più brutale e violenta perché riteneva troppo “moderata” la conduzione di al-Qaeda, che si stava interrogando sulla legittimità di uccidere i civili musulmani. Qualcosa stava, dunque, cambiando.
Nello stesso periodo, negli Stati Uniti si credeva che con l’uccisione di Osama Bin Laden, Al-Qaeda fosse stata definitivamente sconfitta e la minaccia terrorista debellata. Ma, da vicino, la percezione era completamente diversa. In Mali, Callimachi riesce ad avere dei documenti di Al-Qaeda giunti dallo Yemen dopo aver attraversato il deserto e l’oceano, che dimostravano che il gruppo terroristico era sopravvissuto alla morte di Bin Laden, «grazie alla creazione di una struttura non dipendente da una persona sola e capace di rigenerare se stessa».
L’importanza dei social network nell’indagine giornalistica
Callimachi, inoltre, sempre sul campo, nota anche l’importanza per queste organizzazioni terroristiche dei social network, da loro utilizzati sia per gestire le comunicazioni interne sia per fare proselitismo.
Proprio per questo motivo, Callimachi si approccia ai social come se stesse cercando fonti o contatti in una vecchia roccaforte liberata o nei pressi dei territori controllati dai gruppi terroristici. Il lavoro sul campo non è necessariamente (o meglio non solo) quello sul posto e anche i social network sono un luogo dove fare indagine.
Le conversazioni sui social network consentono di comprendere di cosa i jihadisti parlano e, soprattutto, di come ne stanno parlando: «Ad esempio, ultimamente, si parla molto di spie, di decapitazioni di spie, non importa se reali o presunte tali. Questo può significare che siano in difficoltà. Oppure parlano tanto di attacchi aerei. Ogni cosa che cade dal cielo, per loro, è un bombardamento degli aerei della coalizione anti-IS. Vogliono creare la percezione che gli attacchi a Bruxelles e Parigi siano stati una risposta alle aggressioni contro di loro».
I jihadisti, spiega la giornalista a Wired, utilizzano i social network in modo molto intelligente. Il loro canale principale è Twitter, anche se ultimamente stanno sperimentando altre piattaforme, come Tumblr e Instagram: «Twitter è il luogo dove loro 'vanno a pesca di uomini', non parlano a quelli già radicalizzati, ma raggiungono persone che possono essere interessate. Fino al 2012 e al 2013, i jihadisti usavano forum chiusi in lingua araba». Da quando Twitter ha cominciato a chiudere i loro account, si sono spostati su Telegram, una app crittografata, dove possono creare dei canali (simili a delle chat di gruppo), ai quali si può accedere solo conoscendo l’account esatto e su invito.
31. It's important to learn the lingo. Pledging allegiance in ISIS terminology is "pledging bay'ah": https://t.co/9g554W0fec
— Rukmini Callimachi (@rcallimachi) 12 giugno 2016
Ogni social network richiede un approccio differente. «Su Twitter è più semplice, cerco alcune parole chiave, poi seguo alcuni account, poi chi segue quegli account e così a catena», ripercorrendo un filo d’arianna che le consente di entrare in contatto con persone che si sono radicalizzate. Spesso sono contatti Twitter a scriverle e a fare da intermediari. Un aiuto, inoltre, è arrivato dal gruppo 'Anonymous'. Molti di loro sono hacker e si stanno fingendo jihadisti per identificare e poi segnalare account sospetti. C’è chi si sta fingendo jihadista per riuscire ad avere informazioni che altrimenti sarebbero inaccessibili, spingendosi in un tipo di lavoro, prosegue Callimachi, che lei non può fare. Già nel 2012, aveva rifiutato di fingere altre identità per poter entrare nei forum jihadisti, preferendo mantenere un profilo pubblico e riconoscibile per i propri interlocutori.
Su Telegram è tutto più difficile: la giornalista è in contatto con simpatizzanti di gruppi terroristici. Interagire con questi contatti le consente di capire quali sono i canali di Telegram frequentati da jihadisti e soprattutto di tenere il polso di cosa parlano i membri dei diversi gruppi. Molto spesso i canali vengono chiusi, come capitava con Twitter, e ne vengono riaperti altri. Ogni mattina, dice Callimachi, è come la fatica di Sisifo, bisogna ricominciare tutto da capo, i canali validi il giorno prima, quello successivo possono essere stati bloccati o non essere più validi.
La gestione delle fonti
Gli argomenti di discussione delle chat private non diventano necessariamente contenuti citati negli articoli, ma sono utili per capire il contesto in cui i jihadisti si muovono. Inoltre, non conoscere bene l’identità delle persone con cui la giornalista interagisce, impone grande cautela nel momento in cui si scrivono gli articoli: «Ho citato al massimo uno o due jihadisti, perché ho potuto verificare chi fossero. In tutti gli altri casi, non essendo certa di parlare con qualcuno di loro non li cito».
Come nel caso del primo jihadista con cui la giornalista entra in contatto, Oumar Ould Hamana, un comandante di al-Qaeda nel Maghreb islamico, noto agli occidentali rapiti in quella regione perché erano uno dei principali rapitori. Quando il gruppo terroristico riesce a prendere il controllo di Timbuktu, Hamana viene nominato portavoce. Rukmini riesce ad avere il suo numero di cellulare e inizia a sentirlo con una certa frequenza, ogni settimana e, a volte, a distanza di pochi giorni: «Non volevo avere molti contatti con lui, però finalmente mi sentivo come se avessi un interlocutore umano in questo gruppo pazzesco. Potevo contattarlo, inviargli sms, potevamo chiamarlo ogni volta che c’era qualche “breaking news”, come quando hanno annunciato che stavano per distruggere un mausoleo o che avevano lapidato a morte una coppia per adulterio».
Nonostante questi contatti frequenti, però, Callimachi non faceva alcun riferimento nei suoi articoli a quello che il jihadista le raccontava: «Come giornalisti ci viene insegnato di essere molto scettici su queste persone, molto più che nei confronti di qualsiasi altro. Poi sono andata a Timbuktu e mi sono resa conto che le sue descrizioni erano accurate e che non aveva cercato di ingannarmi. (...) Quando a un certo punto si diceva che al-Qaeda stava mettendo sul’arsenale di Gheddafi, lui mi confermò quelle voci. Ma non potevo fidarmi, ero davanti a un terrorista di un’organizzazione che cerca di diffondere paura. (...) Poi, in Mali, ho visto una pila di documenti e una foto con un’arma: erano quelle di Gheddafi! Tra di loro ci sono tante persone che mentono ma anche buone fonti che ti dicono cose veritiere».

Con alcuni di loro, Rukmini non nasconde di aver fatto fatica a mantenere una certa distanza: «Ho parlato circa un anno con un membro di al-Shabaab, un gruppo di al-Qaeda in Africa orientale, con base in Somalia. È il gruppo che ha fatto l’attacco alla Westgate Mall a Nairobi nel 2013. Sono stata messa in contatto con lui da un’altra fonte di al-Qaeda di cui mi fidavo. (...) Mi ha aiutato molto quando c’è stato un attacco terribile del loro gruppo al campus universitario di Garissa, in Kenya. Nell’attacco furono uccise tante ragazze di 19 anni nello loro divise universitarie».
Dopo alcuni mesi di conversazioni on line, la fonte le confida di voler uscire da al-Shabaab: «Ero in una posizione così strana che avevo pensato, per aiutarlo, di trovare un modo per metterlo in contatto con l’FBI. Ma non potevo farlo, sono una giornalista. Non potevo essere coinvolta fino a quel punto. Lui si stava confidando con me e mi stava dicendo tutte le cose che al-Shabaab stava facendo violando la sharia, che proibisce di uccidere donne, bambini e anziani».
La giornalista non lo conosceva bene, non sapeva quanti anni avesse, immaginava fosse giovane: «Parlava inglese molto bene e con molti 'americanismi' da farmi pensare quasi che fosse un cittadino americano. Il suo nome era Bilal. Mi stava mostrando il suo lato umano. Lo vedevo titubante e combattuto. Ho riflettuto a lungo e, alla fine, gli ho detto che l’unica cosa che potevo fare era individuare delle persone sui social media con cui potevo metterlo in contatto se era davvero quella la decisione che voleva prendere».
Bilal risponde a Rukmini di non potersi permettere di entrare in contatto con nessuno del governo americano perché così avrebbe messo in pericolo i propri cari. Dopo un paio di settimane, il giovane somalo le dice di essere sospettato, di rischiare di essere arrestato e di aver dato il suo contatto a un suo amico fidato. Per alcune settimane i contatti si interrompono, c’era stato un violento attacco degli Usa in Somalia con i droni e Rukmini pensa che fosse rimasto ucciso.
Un paio di settimane dopo l’attacco, dall’account Telegram di Bilal arriva un messaggio scritto in un inglese più zoppicante: «Sono un amico di Bilal, mi ha detto di comunicarti che è stato arrestato. È stato accusato di tradimento». Rischiava la condanna a morte. «È dura non provare nulla nei riguardi di persone che sono diventate la tua fonte, nonostante siano appartenenti a gruppi che fanno cose terribili», racconta Rukmini a Slate. Dopo qualche giorno arriva l’email che dice: «L’esecuzione del fratello Bilal è avvenuta oggi, possa Allah accettarlo nella Genna (ndr il Paradiso)».
La storia di Bilal non è isolata. Altre persone con cui Callimachi è entrata in contatto sono morte, per mano dei droni occidentali o dei gruppi terroristici stessi. Oumar Ould Hamaha è stato ucciso in un attacco coi droni in Mali nel 2013. Così anche un altro ragazzo di Al-Qaeda nella penisola arabica, fonte anche di altri giornalisti, e un affiliato dell’Isis.
Alla domanda, fatta da Caitlin Roper su Wired, se si sente sopraffatta da questo tipo di lavoro, Rukmini risponde:
Sono arrivata al punto in cui riesco a metabolizzare abbastanza rapidamente. Mi piace quello che faccio e il mio corpo capisce a quale livello deve mettere una certa distanza tra me e il mio lavoro. La mia prima grande storia come giornalista è stato il terremoto in Gujarat, in India, nel 2001. Non avevo mai visto un disastro naturale di quelle proporzioni, prima. Non avevo mai visto così tante persone morte ammucchiate e ricordo che camminavo per le strade con le lacrime che rigavano il mio viso. È stato così intenso e struggente e grande. Non potrà mai esserci qualcosa come quello, in futuro.