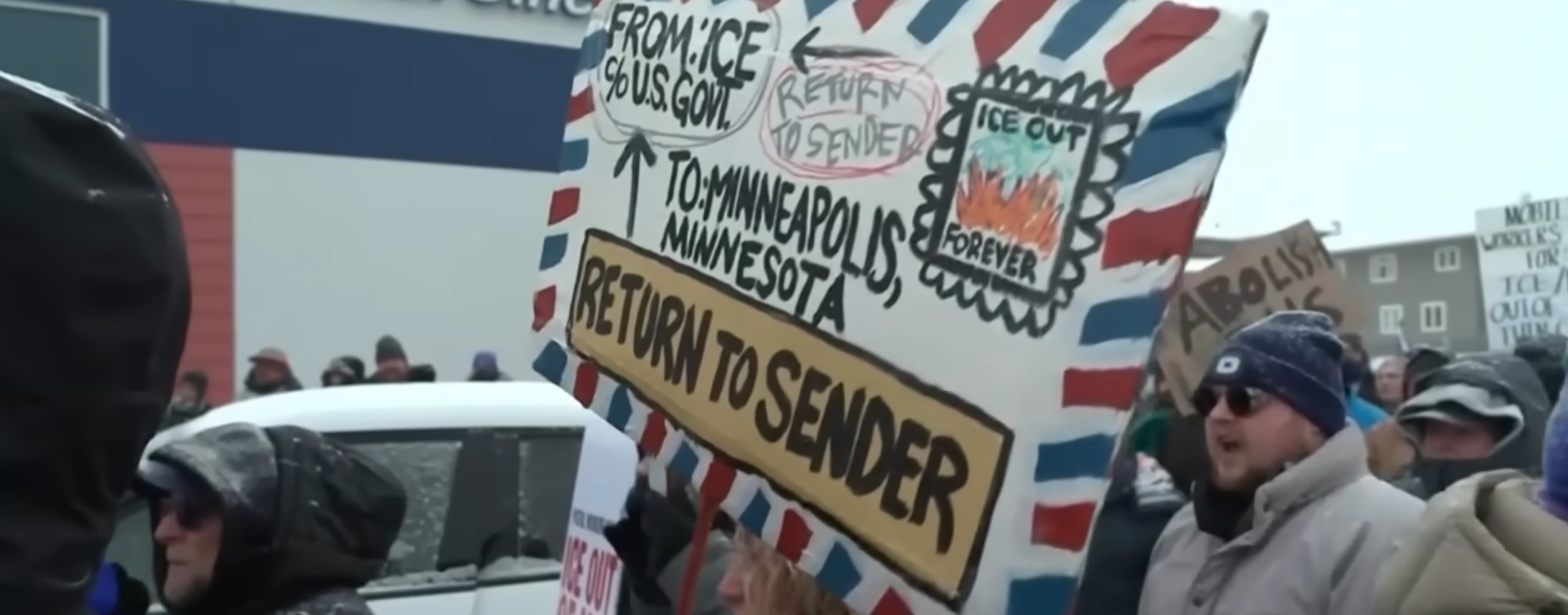Difesa, energia e tecnologia: la strada obbligata dell’indipendenza europea dagli USA
|
|
I matrimoni raramente finiscono di colpo. Più spesso è un lento disfacimento, anni o alle volte decenni di errori e di incomprensioni. Problemi di comunicazione, divergenze incolmabili, infedeltà. E poi arriva la proverbiale ultima goccia, quella che fa traboccare il vaso. La crisi provocata dalle mire di Trump e di alcuni suoi consiglieri sulla Groenlandia sembra essere stata proprio questo: l’ultima goccia in grado di finire la pazienza persino di alcuni tra i più fedeli alleati europei degli Stati Uniti.
Ma appunto, i matrimoni non collassano dalla sera alla mattina. Le relazioni transatlantiche hanno iniziato a indebolirsi da ben prima della seconda amministrazione Trump. Già nel 1956, con la crisi di Suez, divenne chiaro che gli Stati Uniti e gli europei (occidentali) non sarebbero sempre andati d’amore e d’accordo. Nel 1965 fece scalpore The troubled partnership: A re-appraisal of the atlantic alliance, libro di Henry Kissinger che non risparmiava critiche agli Stati Uniti: «[i] decisori politici statunitensi agiscono spesso come se il disaccordo con i loro punti di vista [da parte degli europei] sia dovuto all’ignoranza, da superare con approfondite spiegazioni e insistenti ripetizioni». The troubled partnership era un testo complesso, e – scherzava Kissinger – veniva venduto bene solo in quelle librerie dove finiva nella sezione delle guide per il matrimonio.
Le tensioni tra le due sponde dell’Atlantico crebbero quando l’amministrazione Nixon decise di smantellare gli accordi di Bretton Woods. Nel 1971, a Roma, fu il segretario del tesoro di Nixon, il texano John Connally, a dire ai colleghi dell’Europa occidentale (e a giapponesi e canadesi) che «è il nostro dollaro, è un vostro problema». La condotta a dir poco spregiudicata dell’amministrazione repubblicana segnò un deterioramento dei rapporti tra gli Stati Uniti e l’Europa. Persino i britannici iniziarono a guardarsi intorno, e Kissinger paragonò Nixon a un «amante abbandonato» da Edward Heath (il Primo Ministro che per far entrare il Regno Unito nelle Comunità Europee e blandire i francesi attenuò, secondo taluni, la special relationship tra Londra e Washington).
Furono però la fine della Guerra Fredda e la scomparsa del nemico sovietico a rendere gli europei meno necessari agli occhi di Washington. Nuove opportunità, nuove alleanze e nuove sfide si profilavano all’orizzonte, specialmente in Estremo Oriente, dove i cinesi potevano diventare per l’iperpotenza statunitense quello che i greci erano stati per Roma. Alla fine degli anni ‘90 tra l’Europa e gli Stati Uniti scoppiò la “guerra delle banane”, con il presidente Clinton che suo malgrado impose dazi su alcune esportazioni europee (incluso il pecorino nostrano). Nel 2003 l’invasione (anglo)statunitense dell’Iraq incrinò i rapporti tra Washington e il motore dell’integrazione europea, cioè la Francia e la Germania, già bollate come “vecchia Europa” dal segretario della difesa Donald Rumsfeld in una famosa intervista. Nemmeno la fine della lunga amministrazione Bush e l’arrivo alla Casa Bianca di Barack Obama segnarono un decisivo cambio di passo, nonostante la seducente retorica europeista del nuovo presidente.
Il pivot to Asia obamiano certificò che per gli Stati Uniti la priorità era l’Estremo Oriente. Nel 2014 la reazione, nel complesso contenuta, degli Stati Uniti di fronte all’invasione russa della Crimea non passò inosservata nei paesi nordici e baltici (e neppure al Cremlino). D’altra parte il fallimento degli snervanti negoziati per la TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, accordo commerciale di libero scambio tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea), fortemente voluta da Obama ma osteggiata da pezzi di classe dirigente europea, non piacque all’establishment statunitense. Arrivò poi la prima amministrazione Trump, così aggressiva e isolazionista da destare crescenti preoccupazioni sia in Europa che in Canada.
Ormai è chiaro a tutti che il sodalizio tra gli Stati Uniti e l’Europa è agli sgoccioli. Se forse il divorzio non è ancora alle porte, è evidente che c’è una separazione in casa (cioè la NATO, con un coro di leader europei a reclamare il famoso “pilastro europeo”). La crisi groenlandese, e ancora prima il bullismo verbale di Trump, Vance e altri esponenti apicali del Trump cabinet nei confronti degli europei, la National Security Strategy così ostile all’UE e lo scarso (e intermittente) sostegno della Casa Bianca all’Ucraina sembrano aver allargato a dismisura l’Atlantico, che ancora ieri i britannici chiamavano con affettuosa ironia the pond, lo stagno.
L’Europa non è più vista da certi repubblicani come un interlocutore primario, ma come un competitor politico che tradisce i valori condivisi con gli Stati Uniti, frena la libertà di parola, non controlla i flussi migratori, colpisce le imprese americane. L’Europa si sta trasformando in un’anti-America, così come Taiwan (ufficialmente Repubblica di Cina) appare agli occhi di Pechino come un’anti-Cina, e l’Ucraina è per Putin un’anti-Russia.
Pochi giorni fa, parlando in forma anonima alla CNN, un diplomatico europeo ha definito la crisi groenlandese «un vortice di assurdità che danneggia le relazioni transatlantiche, distoglie l’attenzione dall’Ucraina e rende molto felici Cina e Russia». Altri funzionari si sarebbero persino spinti più in là, dichiarando che la postura di Trump sulla Groenlandia ha cambiato in modo irrevocabile le relazioni transatlantiche. Il Financial Times ha scelto il lirismo: «Come il ghiaccio artico, sembra che le relazioni transatlantiche si stiano fratturando rapidamente». Al lessico da crisi matrimoniale ha attinto pure Eliot A. Cohen, politologo conservatore ed ex consigliere del dipartimento di stato ai tempi di Condoleezza Rice; una sua recente riflessione su The Atlantic è intitolata “il grande divorzio”.
Il pessimismo, comprensibilmente, è forte nei paesi nordici. L’opinione pubblica danese, in particolare, è traumatizzata. Per il quotidiano di Copenaghen Berlingske il 2025 è stato l’anno in cui «gli amici sono diventati nemici, o quasi». Anche la classe dirigente nordica è turbata, ma non stupita. Già nel febbraio del 2025 l’ex Statsminister del Regno di Danimarca – nonché ex segretario generale della NATO – Anders Fogh Rasmussen osservava dalle pagine del settimanale The Economist che «le relazioni transatlantiche stanno crollando», e che l’Europa avrebbe dovuto prenderne atto. È bene rilevare, per chi conosce poco la politica danese, che Rasmussen non è un esponente della sinistra anti-USA, e nemmeno un socialdemocratico irenico: è un liberale di destra, e ha guidato il Regno nei nefasti anni di George W. Bush alla Casa Bianca, inviando forze danesi sia in Afghanistan che in Iraq (non senza subire durissime critiche in patria).
Pochi giorni fa l’ex Forsvarssjefen (capo della difesa) del Regno di Norvegia Sverre Diesen ha dichiarato al quotidiano finanziario norvegese Dagens Næringsliv che gli Stati Uniti sono diventati «una repubblica delle banane neofascista». Parole durissime da chi, fino al settembre del 2009, era secondo solo al re di Norvegia nella gerarchia militare di un paese politicamente molto legato al Regno Unito e agli Stati Uniti.
Nel resto del continente la preoccupazione è altrettanto forte. Alla Reuters fonti diplomatiche hanno detto che a causa della crisi groenlandese i leader europei riconsidereranno le relazioni con gli Stati Uniti. Molti capi di Stato e di governo sembrano però credere che non tutto sia perduto. È il caso del cancelliere tedesco Friedrich Merz, da sempre grande estimatore degli Stati Uniti: «[n]onostante tutta la frustrazione e la rabbia degli ultimi mesi, non affrettiamoci a dare per finita la partnership transatlantica». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sembra pensarla alla stessa maniera, anche perché il suo rapporto privilegiato con Trump è tra gli asset del governo a Bruxelles. Roma e Berlino sono allineate: nel recentissimo Protocollo su un piano d’azione italo-tedesco per la cooperazione strategica bilaterale e nell’ambito dell’UE si può leggere che entrambi i governi «[r]iconfermano la fondamentale importanza di un forte legame transatlantico tra l’Europa e gli Stati Uniti, basato su valori comuni e interessi condivisi».
Il primo ministro polacco Donald Tusk ha riconosciuto che i rapporti tra l'UE e gli Stati Uniti sono «in crisi», ma vanno comunque protetti, «benché oggi sia molto più difficile che mai». Dietro le quinte persino il presidente francese Emmanuel Macron, il più adamantino tra i leader europei, ha sempre evitato la rottura con Trump, rivolgendosi a lui con un tono non così diverso da quello, oltremodo ossequioso, del Segretario generale della NATO Mark Rutte.
Washington, intanto, continua a buttare benzina sul fuoco; il sospetto che, alla Casa Bianca, qualcuno voglia davvero provocare un divorzio tra l’Europa e gli Stati Uniti diventa sempre più verosimile: le vergognose parole di Trump sui soldati europei e canadesi rimasti «un po’ indietro» in Afghanistan sono riuscite a far arrabbiare persino Meloni e il Primo Ministro britannico Keir Starmer (forse il leader europeo più “rispettato” alla Casa Bianca, grazie anche all’influenza della famiglia reale).
L’imperativo dell’autonomia strategica
È ovvio che i Trump vanno e vengono, e gli Stati Uniti restano. Tuttavia, come si è accennato sopra, è da molti anni che gli Stati Uniti non considerano più l’Europa come la loro priorità. L’URSS è collassata molti anni fa, e non c’è più il rischio che una superpotenza ostile allo stile di vita americano si impadronisca manu militari del secondo polo industriale del pianeta; non nel breve termine, almeno. E se la Casa Bianca oggi non ha un alleato n° 1 (a meno che non si consideri tale Starmer), è plausibile che prima o poi un successore di Trump scelga di puntare sull’India ultranazionalista, o su un Giappone più assertivo, ovviamente in funzione anti-cinese.
L’Europa, dunque, deve agire, concretizzando l’“autonomia strategica aperta” promessa nel 2019 dalla “commissione geopolitica” di Ursula von der Leyen di fronte al Parlamento Europeo in plenaria, ovverosia «[l]a capacità della UE di agire in modo autonomo (cioè senza dipendere da altri paesi) in ambiti politici strategicamente importanti, legati sia alla sfera economica che a quella non economica [come] l’energia, la ricerca, la sanità, i media, la tecnologia, la difesa, l’alimentazione, l’industria» e di promuovere nel mondo la libertà, la democrazia e un ordine internazionale fondato su regole.
Nel 2022 l’allora pääministeri finlandese Sanna Marin auspicò che l’Europa rafforzasse la sua autonomia strategica nell’energia, nella produzione militare, nella sovranità alimentare e nella tecnologia. A oggi non sembra che sia stato fatto molto. O comunque, non abbastanza.
In ambito energetico l’Europa ha posto fine, almeno in parte, alla sua dipendenza energetica dalla Russia putiniana, ma ha sostituito l’importazione di gas russo con quella di gas naturale liquefatto statunitense. Nell’ambito della sovranità alimentare, più volte il mondo agricolo europeo ha segnalato che il Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034 rischiava di infliggere un colpo fatale alla PAC post-2027; alla fine Bruxelles è tornata sui suoi passi, aumentando il budget destinato agli agricoltori, ma è evidente che in un mondo in pieno boom demografico, e dove le potenze autocratiche possono mettere a rischio la sicurezza alimentare globale, l’Europa deve poter contare su un’agricoltura resiliente, sostenibile e ben sostenuta.
In ambito tecnologico la dipendenza europea dagli Stati Uniti è, in alcuni settori, fortissima. Come ha dichiarato al Financial Times all’inizio del 2026 Miguel De Bruycker, direttore del Centre for Cybersecurity Belgium (CCB), è impossibile al momento conservare tutti i dati in Europa a causa del predominio statunitense sulle infrastrutture digitali. «Abbiamo perso l’intero cloud. Abbiamo perso internet» ha ammesso De Bruycker.
I computer e gli smartphone che ogni giorno i cittadini e le aziende della UE usano sono quasi tutti fabbricati in Estremo Oriente, e si avvalgono di sistemi operativi statunitensi o cinesi. Anche nella mobilità di nuova generazione Cina e Stati Uniti incalzano: tra il gennaio e il giugno 2025 i due BEV (battery-electric vehicle) più venduti nel continente sono stati la Tesla Model Y e Model 3, mentre il terzo e il quarto PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) sono stati, rispettivamente, la cinese BYD Seal U e la Ford Kuga. Fino a pochi anni fa l’automotive era uno dei pilastri del manifatturiero europeo, mentre oggi cresce il timore, tra gli addetti ai lavori, di essere spazzati via in un decennio o meno dalla concorrenza cinese, che – tra le altre cose – vanta cicli produttivi più brevi e forti ecosistemi industriali, massicciamente sostenuti dal governo.
Ancora, nessuna delle aziende leader nel campo dell’Intelligenza Artificiale è europea; come ha osservato al WEF di Davos Eric Schmidt, ex AD di Google, «è davvero importante che l’Europa crei un modello open source guidato dagli europei. Le aziende statunitensi stanno passando per la maggior parte al closed source [...] La Cina ha un approccio prevalentemente open-weight e open-source […] Quindi, a meno che l’Europa non faccia qualcosa e non sia disposta a spendere molto denaro per dei modelli europei, finirà per utilizzare quelli cinesi. Probabilmente questo non sarà un buon risultato per l’Europa». A parere di Schmidt uno dei punti di debolezza dell’Europa è il costo dell’energia, cruciale considerando che i data center sono altamente energivori. Un altro è che il continente non ha una strategia precisa per l’IA, mentre è noto che gli statunitensi puntano alla cosiddetta Intelligenza Artificiale Generale (AGI), e i cinesi, meno ambiziosi ma più pragmatici, vogliono rendere l’IA ubiqua.
Naturalmente all’Europa non difetta il know-how industriale, né mancano le competenze di tipo tecnoscientifico. Il problema è che il continente da almeno tre decenni non produce nuovi colossi aziendali in grado di assumere la leadership in settori così cruciali, e di catalizzare gli sforzi, a differenza di quanto accade negli Stati Uniti e in Cina. Realtà di estremo successo come NVIDIA, Tesla, Tencent e BYD sono nate tra i primi anni ’90 e l’inizio di questo secolo, e in meno di trent’anni hanno raggiunto fatturati da 80-100 miliardi di dollari, conquistando posizioni di supremazia tecnologica indiscussa o quasi.
Infine, la difesa è il vero tallone d’Achille del continente. Ai confini dell'UE, così come in Africa e in Medio Oriente, sono in corso guerre e occupazioni di inaudita ferocia. E dinanzi a un crescente disimpegno statunitense dall’Europa (al di là delle dichiarazioni di Trump, si pensi solo alla fortissima contrazione del sostegno militare e finanziario statunitense all’Ucraina dal gennaio del 2025) le forze armate europee si scoprono impreparate ad affrontare un conflitto tra pari, come quello che dal 2022 gli ucraini combattono contro l’aggressore russo.
In gran parte dei paesi europei il concetto di difesa resta legato, nella sostanza anche se non nei white papers, ai paradigmi post-Guerra Fredda di inizio XXI secolo, quando l’orizzonte era quello dei conflitti asimmetrici, contro i talebani in Afghanistan o gli insorti in Iraq. Certo, ci sono eccezioni, come la Finlandia, che può contare su un bacino di 870mila riservisti e in caso di guerra può dispiegare quasi 300mila unità.
Si considerino ad esempio le forze armate britanniche, che ancora nel 1982 erano in grado di combattere, e vincere, una guerra convenzionale contro una media potenza (l’Argentina della giunta militare) in un teatro remoto come le isole Falkland. Secondo uno studio del Royal United Services Institute, nel 2022 le scorte di munizioni erano “gravemente insufficienti”, bastevoli per una settimana di combattimenti à l’ukrainienne. Nel 2024 l’ex sottosegretario di stato per le forze armate John Spellar ha dichiarato che l’esercito britannico «finirebbe le munizioni in dieci giorni».
Ed è noto che tanto la RAF che la Royal Navy e la British Army soffrono una drammatica carenza di uomini e di mezzi. Nel rapporto “Aviation Procurement: Winging it?” del 2023 il Comitato per la difesa della Camera dei Comuni ha sottolineato che i tagli alle capacità aeree decisi nel Defence Command Paper del 2021 pongono seri dubbi sul fatto che la RAF sia «in grado di scoraggiare e difendere con successo il paese da un’aggressione nemica. Sebbene composta da velivoli altamente performanti, [la flotta] è semplicemente troppo piccola per resistere ai livelli di logoramento che si verificherebbero in una guerra tra pari».
Ancora, c’è ansia anche per la Royal Navy, storico simbolo della potenza militare britannica, in particolare per «le dimensioni della flotta e le potenziali lacune a livello di capacità causate dai ritardi nella messa in servizio delle nuove navi». Nel giugno del 2025 l’ammiraglio Tony Radakin ha ammesso che la marina è in una fase di «difficile transizione», con i rimpiazzi delle vecchie fregate «non ancora pronti». Più in generale, il numero di militari di carriera e riservisti «è in continuo declino», e tale è la preoccupazione che Londra vuole offrire ai neo-diplomati e neo-laureati l’opportunità di entrare nelle forze armate per un limitato lasso di tempo senza un impegno a lungo termine.
La situazione non è migliore altrove, ad esempio in Germania. L’esercito tedesco fatica con gli arruolamenti, e nel 2024 il ministro della difesa, il socialdemocratico Boris Pistorius si è provocatoriamente interrogato su chi dovrebbe difendere il paese. Due anni prima aveva fatto scalpore la notizia che le forze armate tedesche avevano munizioni per appena due giorni di combattimenti; certo, la cosa non era mai stata confermata ufficialmente, ma il paese era corso ai ripari, tant’è vero che entro il 2027 la Rheinmetall dovrebbe raggiungere una produzione annua di 1,5 milioni di proiettili da artiglieria da 155 millimetri.
Anche nel resto del continente la produzione di proiettili sta aumentando. Ma la sfida non è solo quella di assicurare abbastanza da sparare agli artiglieri tedeschi o britannici. Ad esempio, l’aeronautica francese, secondo quanto emerso nel febbraio del 2025, non potrebbe sostenere più di tre giorni di intensi combattimenti, dopo i quali esaurirebbe i missili. E il già citato Radakin, alla domanda «[s]e gli Stati Uniti ritirassero il loro contributo alla NATO o la loro presenza qui in Europa, in tutto o in parte, l’Europa sarebbe ancora abbastanza forte da tenere testa alla Russia?» replicava in modo degno di nota: prima lodando la profondità strategica dell’Europa, grazie al suo mezzo miliardo di persone e alle sue «economie incredibili», poi rifiutando la premessa e sottolineando che «l’America resta fedele alla NATO».
Ciò che l’ammiraglio britannico non ha voluto esplicitare pochi mesi fa è stato detto senza tanti giri di parole da Rutte pochissimi giorni fa. Secondo il Segretario generale della NATO, «se qualcuno […] pensa che la UE o l’Europa nel suo complesso possano difendersi senza gli Stati Uniti, continui a sognare»; per il segretario generale della NATO rinunciare al supporto statunitense significherebbe aumentare notevolmente i budget per la difesa, trovare uomini e donne da arruolare, costruire un costosissimo ombrello nucleare. Ma per il ministro francese dell’Europa e degli esteri Jean-Noël Barrot Rutte sbaglia: «Gli europei possono e devono farsi carico della propria sicurezza. Anche gli Stati Uniti sono d’accordo». E in effetti il giorno in cui il continente dovrà imparare a proteggersi da solo sembra sempre più vicino.
Che fare, dunque? Alcune idee
Prendendo spunto dal coraggioso discorso del primo ministro canadese Mark Carney al WEF di Davos, occorre «diversificare all’estero». La UE deve rafforzare le partnership con paesi dai valori condivisi (e dalla solida democrazia) come il Canada stesso, il Brasile e il Giappone. Forgiare, cioè, una coalizione di medie potenze e di grandi potenze riluttanti (come la UE stessa) accomunate dalla volontà di preservare un ordine internazionale basato su regole e di bilanciare il revisionismo di Stati Uniti, Russia ecc. Il già citato Rasmussen ha recentemente proposto su EUobserver di creare un D7 che includa, oltre alla UE, al Canada e al Regno Unito, anche il Giappone, la Corea del Sud, l’Australia e la Nuova Zelanda.
In effetti c’è crescente sintonia tra Bruxelles, Londra, Ottawa, Canberra e Tokyo. I legami tra la UE e il Regno Unito si stanno intensificando, dopo il grande gelo causato dalla Brexit. Il Canada, ma anche il Giappone, la Nuova Zelanda e l’Australia, appoggiano la “coalizione dei volenterosi” per l’Ucraina. La partnership tra Ottawa e Bruxelles è sempre più forte e ampia. Il Giappone sta sviluppando, con il Regno Unito e l’Italia, il GCAP, caccia stealth di sesta generazione.
Gli europei farebbero bene però a non trascurare l’America Latina, soprattutto il Brasile. Un paese che, pur con le sue fragilità e contraddizioni, mostra grande vitalità non solo dal punto di vista demografico ed economico, ma democratico (come suggerisce la condanna a 27 anni di carcere decisa dal Supremo Tribunal Federal di Brasilia nei confronti dell’ex presidente Jair Bolsonaro).
La diversificazione deve essere geopolitica, tecnologica, energetica, commerciale; l’accordo UE-Mercosur non è perfetto, e non deve andare a detrimento della salute dei cittadini europei o della sicurezza alimentare continentale, ma è cruciale per legare alla UE una grande area economica sotto molti aspetti complementare, e per sostenere le democrazie della regione. È poi opportuno un rapporto più stretto con il Messico, che è sì alle prese con una grave crisi interna, ma ha un enorme potenziale politico, culturale e commerciale, ed è oggi guidato da una delle leader americane più capaci.
Occorre invece molta più cautela nei confronti dell’India, grande potenza che negli ultimi anni ha voltato le spalle alla sua tradizione democratica, e degli Emirati Arabi Uniti, che di democratico hanno ben poco (si pensi solo alla loro condotta in Yemen e in Sudan). Se c’è una lezione che l’UE dovrebbe aver imparato dai suoi fallimenti con la Russia, è che i regimi autoritari (o le democrature) non sono partner affidabili nel medio-lungo periodo.
Diverso è invece il discorso con medie potenze africane e asiatiche democraticamente solide, o almeno in ripresa democratica, come il Sudafrica, il Ghana e persino il Bangladesh. In questi casi è essenziale un maggior engagement da parte degli europei, perché trascurare Pretoria, Dhâkâ, Accra e così via potrebbe rafforzare ulteriormente l’influenza in quei paesi della Cina e della Russia, e alimentare processi di involuzione politica ed economica. Al contrario, una UE decisa a promuovere (in modo intelligente e rispettoso) la democrazia e i diritti umani nel mondo, in realtà contribuisce alla sua stessa prosperità, e crea un ambiente non-favorevole alle grandi e medie potenze autocratiche del pianeta.
Di fronte a uno scenario globale in profonda evoluzione gli europei possono ispirarsi a quello che il presidente finlandese Alexander Stubb ha definito “realismo basato su valori”, e che Carney riformula come una sorta di pragmatismo dai solidi principi. È chiaro, per esempio, che la UE non può mutare la traiettoria politica di paesi popolosi, potenti e lontani come la Cina, l’Indonesia o il Vietnam. Ed è altrettanto chiaro che non si può non avere un dialogo con Pechino, Jakarta o Hà Nội. Tuttavia questo non significa rinunciare ai principi della Carta delle Nazioni Unite, o alla difesa dei diritti umani. Se la Norvegia, dopo l’assegnazione del Nobel per la pace al dissidente cinese Liu Xiaobo, ha saputo tenere testa (almeno un po’) alla Cina, perché mai la UE non potrebbe fare lo stesso, ove necessario?
Diversificazione è una parola chiave anche per l’autonomia energetica europea, che passa necessariamente da un allargamento della cerchia di fornitori di energia (puntando in primo luogo sui paesi africani). Ciò non significa frenare la transizione energetica, anzi: essa deve accelerare; tuttavia è imperativo abbandonare ogni forma di ingenuità, per esempio verso la Cina, e occorre appoggiarsi soprattutto a soluzioni e tecnologie europee.
Bisogna rifiutare le logiche binarie. Specialmente in campo tecnologico. All’intransigenza di chi vorrebbe recidere subito ogni legame con il Big Tech statunitense, e al disfattismo di chi ritiene l’Europa incapace di fare innovazione dirompente, si deve rispondere con ambizione, coraggio e sano realismo. Il nostro continente oggi non può fare a meno delle infrastrutture digitali statunitensi; al contempo, però, esso è un mercato cruciale per i colossi d’Oltreoceano, e se i governi europei agiscono in modo coeso e coordinato possono confrontarsi con essi, se non da una posizione di forza, almeno di parità.
Inoltre è importante promuovere l’uso di tecnologie europee alternative a quelle statunitensi. È notizia di pochi giorni fa che dal 2027 la pubblica amministrazione francese dovrà usare una piattaforma nazionale per videoconferenze, anziché i popolari equivalenti statunitensi. Nel Regno Unito i liberali democratici chiedono al governo di usare tecnologia britannica anziché soluzioni statunitensi come quelle fornite dalla Palantir. E sempre più europei scelgono, per la loro comunicazione digitale, soluzioni continentali come SwissTransfer, Proton Mail e Mastodon. Senz’altro il sostegno dei cittadini, specie degli early adopters, può aiutare una tech company europea a crescere, e ad attirare investitori. Ma non basta.
Come il debito, anche la burocrazia può essere buona o cattiva. Occorre sburocratizzare dove è possibile, così da semplificare la vita ai nuovi imprenditori high-tech europei, eccellenti ma a corto di capitale finanziario e relazionale (decifrare una normativa, compilare l’ennesimo form, andare da un notaio per cambiare una frase di uno statuto richiede tempo, energia e spesso anche molti soldi, tutte risorse da investire invece in prodotti e servizi migliori). E a chi non crede che le startup continentali possano fare la differenza va ricordato che c’è stato un tempo, piuttosto recente, in cui NVIDIA e Tesla erano semplici startup. Urge poi mobilitare i capitali privati europei, e spingerli a investire su chi innova. Serve, quindi, un vero mercato finanziario unico, perché senza risorse molto ingenti è impensabile raggiungere i livelli di ecosistemi dell’innovazione apicali come la Silicon Valley, Boston o Shenzhen.
Quanto alla difesa, sembra improbabile che si riesca a creare in tempi brevi una “forza militare europea” come proposto di recente dal commissario per la difesa e lo spazio Andrius Kubilius. Un’aggressione russa a un piccolo paese UE potrebbe verificarsi tra due o tre anni, e come si è osservato proprio in questa sede modificare i trattati (o stipularne un nuovo) «è un percorso giuridico lungo e complesso, e l’ostruzionismo di stati membri filorussi potrebbe rimandare sine die la creazione di forze armate agli ordini di Bruxelles». In poche parole, manca il tempo.
Si può però favorire una maggior cooperazione militare tra europei, come già fanno i nordici con il NORDEFCO. Si possono sostenere scaleup della difesa e dell’aerospaziale quali Isar Aerospace, Helsing e Harmattan AI, e in generale investire su abilitatori della difesa come sistemi satellitari e tecnologie per il rifornimento aereo. Si possono modernizzare e potenziare le infrastrutture continentali, quali strade, ferrovie e ponti, in modo da facilitare i movimenti di truppe e mezzi dal Portogallo all’Estonia (corridoio di Suwałki permettendo). Si può creare una “legione europea” come proposto, ad esempio, dal ministro degli esteri polacco Radosław Sikorski, aggirando il Trattato di Lisbona attraverso un’azione congiunta tra stati membri like-minded, come i paesi baltici, intenzionati a contare di più a Bruxelles ma con un’esigua base demografica per gli arruolamenti (del resto la Francia, la Spagna e – fuori dalla UE – il Regno Unito impiegano da tempo soldati stranieri). Si possono lanciare operazioni difensive europee come Aspides (Mar Rosso) anche in altre aree critiche, ad esempio nell’Artico e nell’Atlantico del Nord.
È necessario un cambiamento di mentalità. In una recente intervista a Repubblica Mychajlo Podoljak, consigliere del presidente ucraino Zelens’kyj, ha invitato l’Europa a essere «più proattiva» stigmatizzando «disunione, lunghe discussioni, riluttanza ad adottare decisioni responsabili, lentezza nelle sanzioni e nei nuovi investimenti». Il continente deve «muoversi più velocemente e occupare il proprio posto globale, che oggi è cambiato». Forse Podoljak è troppo brusco, e le sue parole possono suonare ingenerose, ma nella sostanza ha ragione.
L’Europa, del resto, deve sostenere con maggior determinazione lo sforzo bellico ucraino, che dal 2022 sta tenendo a bada uno degli eserciti più forti del mondo, e arrecando enormi danni al complesso militar-industriale russo; e una volta terminata la guerra, dovrà valorizzare in tutti i modi possibili il know-how e l’esperienza delle forze armate dell’Ucraina, così come le sue imprese della difesa. Se in Russia c’è chi arriva a scrivere il necrologio del carro armato, è perché i droni ucraini sono tra i più efficaci al mondo, grazie a un’industria all’avanguardia. In generale l’Ucraina costituisce un “laboratorio” di peso nell’innovazione militare. Conta poi il fattore umano. Gli ucraini (e le ucraine) sanno combattere. Nessun esercito dell’Occidente, neanche quello statunitense, conosce il volto della guerra moderna quanto i soldati ucraini.
Per quanti droni AI-based Bumblebee possano volare sopra i campi di battaglia, è la fanteria nelle trincee e nei bunker che «tiene la posizione». Ecco perché Bruxelles, Parigi, Berlino, Roma, Varsavia, ecc. devono non soltanto fare di tutto perché Kyïv ottenga la pace più giusta possibile, ma anche accelerare l’integrazione del paese esteuropeo nella UE. Così, se anche il divorzio tra le due sponde dell’Atlantico dovesse infine concretizzarsi, con l’Ucraina come nuovo stato membro la UE potrà guardare al futuro con un po’ più di serenità. E come è emerso da un recentissimo scoop di Politico, c’è da sperare che un eventuale divorzio - così la ministra finlandese degli esteri Elina Valtonen in un cablo riservato del Dipartimento di Stato - non sia troppo caotico. Ma come insegna un grande film statunitense, La guerra dei Roses, “un divorzio civile è una contraddizione in termini”.
Immagine in anteprima via Flickr.com