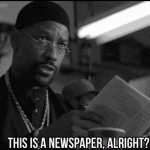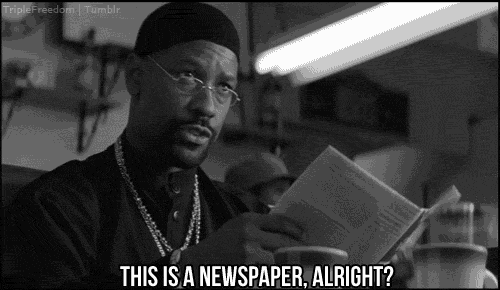Tecniche di sopravvivenza per giornalisti (un po’) alla deriva
5 min letturaImmaginate un articolo di giornale (o un’inchiesta composta di più articoli) che invece di concludersi (o aprirsi) con la firma del “giornalista” che l’ha scritto, come siamo stati abituati a vedere fino ad oggi, riportasse in calce tutti i “credits” professionali che ne hanno reso possibile la stesura: questo articolo è stato realizzato da tizio (scrittura), caio (ricerca e analisi dei dati), sempronio (infografiche) e così via, con un nome e un cognome - magari linkati alle rispettive schede biografiche, ai profili sui social network – per ciascuna delle attività che stanno dietro a un lavoro giornalistico.
In questo modo il lettore potrà conoscere per esempio l’autore del titolo (o più in generale dell’editing: quante volte si accusa ingiustamente un articolista di aver tradito il senso del proprio pezzo con un titolo sensazionalistico, o addirittura sbagliato, che però è responsabilità di un oscuro caporedattore?), sapere chi ha curato la verifica delle fonti, chi ha scelto le fotografie – e fin qui si tratta di attività tradizionalmente giornalistiche – ma anche chi si è occupato di monitorare Twitter alla ricerca di approfondimenti, chi ha realizzato il cosiddetto fact-checking sulle affermazioni contenute nel testo, chi ha creato i link intertestuali o si è occupato di “taggare” l’articolo nel modo più appropriato per inserirlo all’interno di uno o più topic tematici, chi infine è incaricato di interfacciarsi con gli utenti per raccogliere le loro reazioni, i suggerimenti e integrazioni. Si tratterebbe, insomma, di aggiungere quelle informazioni che normalmente al cinema si vedono nei titoli di coda, con la differenza che quell’elenco di giornalisti diventerebbe parte integrante dell’articolo stesso, che da quel momento in poi comincerebbe a vivere di vita propria, arricchendosi e diffondendosi grazie alla rete di relazioni di (e tra) ciascuno dei componenti di quel team. E non è neppure necessario che gli specialisti siano tutti “organici” alla testata: si potranno (o forse si dovranno) creare forme di collaborazione tra soggetti diversi, partnership con chi magari fornisce solo un tipo di servizio ma lo fa al meglio, come ad esempio Graphic News nel settore dell’infografica.
Specializzazione spinta, collaborazione e responsabilizzazione reciproca, capacità di lavorare in squadra e di fare sintesi, valorizzazione biunivoca tra “brand” personali e aziendali: in uno scenario del genere, di fronte a una “notizia” (in senso lato) elaborata, curata e divulgata da una squadra di specialisti ciascuno con le proprie competenze, la propria identità e la propria credibilità - messe però al servizio di un progetto comune, cioè l’informazione – è logico immaginare un delta di valore, dato dalla qualità e dall’affidabilità dello staff rispetto alla stessa “notizia” riportata attraverso fonti indirette per esempio da un singolo blogger o da un sito aggregatore che non può permettersi un tale livello di approfondimento. Il punto è: questo delta potrebbe avere anche un corrispettivo valore commerciale, sia per l’utente che per l’inserzionista pubblicitario?
È una domanda a risposta aperta, ovviamente. Ma è quanto di più concreto e vicino si possa immaginare rispetto al concetto di giornalismo “post-industriale” che emerge dall’approfondito rapporto della Columbia Journalism School uscito in questi giorni e già analizzato sotto molti punti di vista per esempio da Mario Tedeschini Lalli, Pierluca Santoro, Sergio Maistrello, Luca De Biase; o, per chi ha dimestichezza con l’inglese, da un’ottima sintesi del Nieman Lab corredata da chiose critiche.
Proprio quest’ultimo post contiene un approfondimento sul quale vale la pena soffermarsi.
Uno dei temi affrontati dal rapporto della Columbia è quello dell’inutile moltiplicazione delle notizie che si riscontra sul web: basta cercare una parola o un tema chiave su Google per vedersi restituire decine di volte lo stesso lancio di agenzia copiato e incollato su differenti siti o testate. Il web, dicono gli autori, «toglie valore alla necessità di dare la stessa identica notizia a St Louis e a San Luis Obispo». L’obiezione di Joshua Benton, autore del post del Nieman Lab, pone il problema sotto un’altra luce, indicativa di come i cambiamenti in atto nell’ecosistema informativo rendano talvolta necessario rivedere anche le convinzioni più acclarate.
Dice Benton infatti che non c’è alcuna competizione tra i siti di news di Saint Louis e quelli di San Luis Obispo e di fatto nessuna possibilità concreta che uno stesso utente li legga entrambi. Dunque, se è vero che arrivare a una notizia tramite un motore di ricerca provoca un effetto di ridondanza e ripetizione, «ma se guardi dal punto di vista di un lettore che ha un senso di fedeltà verso il giornale di San Luis Obispo – e fedeltà in questo caso non significa un semplice attestato di stima, significa che lo ritieni un posto utile per avere notizie – avere quel lancio d’agenzia sul proprio sito in questo caso aggiunge valore. Elimina il “costo della scoperta” per il tuo lettore; promuove il valore del tuo sito come un filtro editoriale; ti dà qualcosa accanto alla quale mettere un’inserzione pubblicitaria». In altre parole si tratta di un avvertimento contro l’eccessiva “nicchificazione” (nel senso di nicchie informative) da parte dei media, perché il problema della ripetizione dei contenuti è sentito solo da chi ha una dieta mediatica ad alta intensità. Ma la maggior parte delle persone non ha centinaia di feed Rss da seguire, si informa sporadicamente consultando un ristretto numero di siti ed è in fondo beneficiata dalla duplicazione dei contenuti.
L’annotazione di Benton consente una piccola digressione sulla cosiddetta Google tax, cioè la battaglia che alcuni governi, in cartello con gli editori del proprio paese (in particolare Francia e Germania), stanno conducendo per costringere il motore di ricerca a pagare l’indicizzazione dei contenuti giornalistici. Non è il caso di dilungarsi su chi abbia ragione o torto (altri lo hanno già fatto in maniera esaustiva e ciascuno è libero di pensarla a modo suo) quanto su un altro aspetto della vicenda: la sensazione che, tra gli utenti della rete, il partito dei “pro-Google” sia nettamente più numeroso rispetto a chi solidarizza con gli editori. Un apparente paradosso, visto che l’eventuale tassa non ricadrebbe sull’utente finale e anzi consentirebbe agli editori di incamerare denaro senza costringerli a cercare entrate da altre fonti, come per esempio i tanto vituperati paywall. Inoltre, la tassa consentirebbe di portare nelle casse dei singoli stati quel contributo fiscale che, secondo le accuse più recenti, Google cerca di eludere – a torto o a ragione – in virtù della propria entità transnazionale. In realtà Google rappresenta un ideale di rete libera e accessibile a tutti e gode di un’immagine positiva data dall’efficienza e dalla gratuità del servizio. Il contrario di quel che accade per le aziende editoriali in genere, che non possono vantare la stessa fama. Ecco perché, invece di preoccuparsi della tassa su Google, forse l’industria giornalistica dovrebbe cominciare a investire in una tassa sulla fiducia da parte dei propri “consumatori”: un’opzione faticosa, ma non più derogabile.