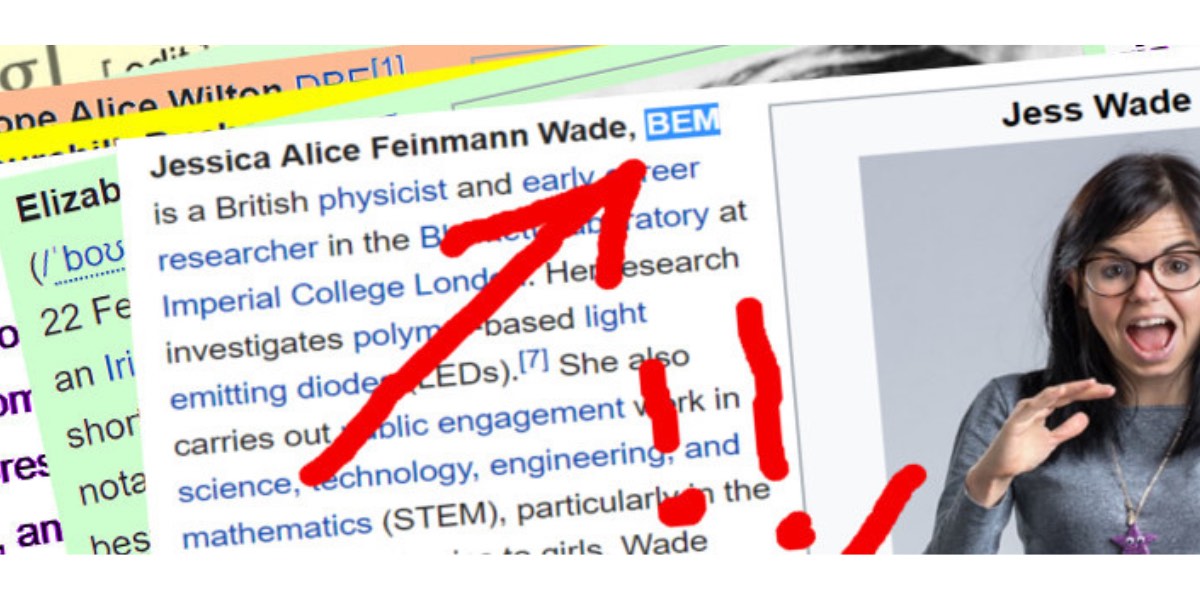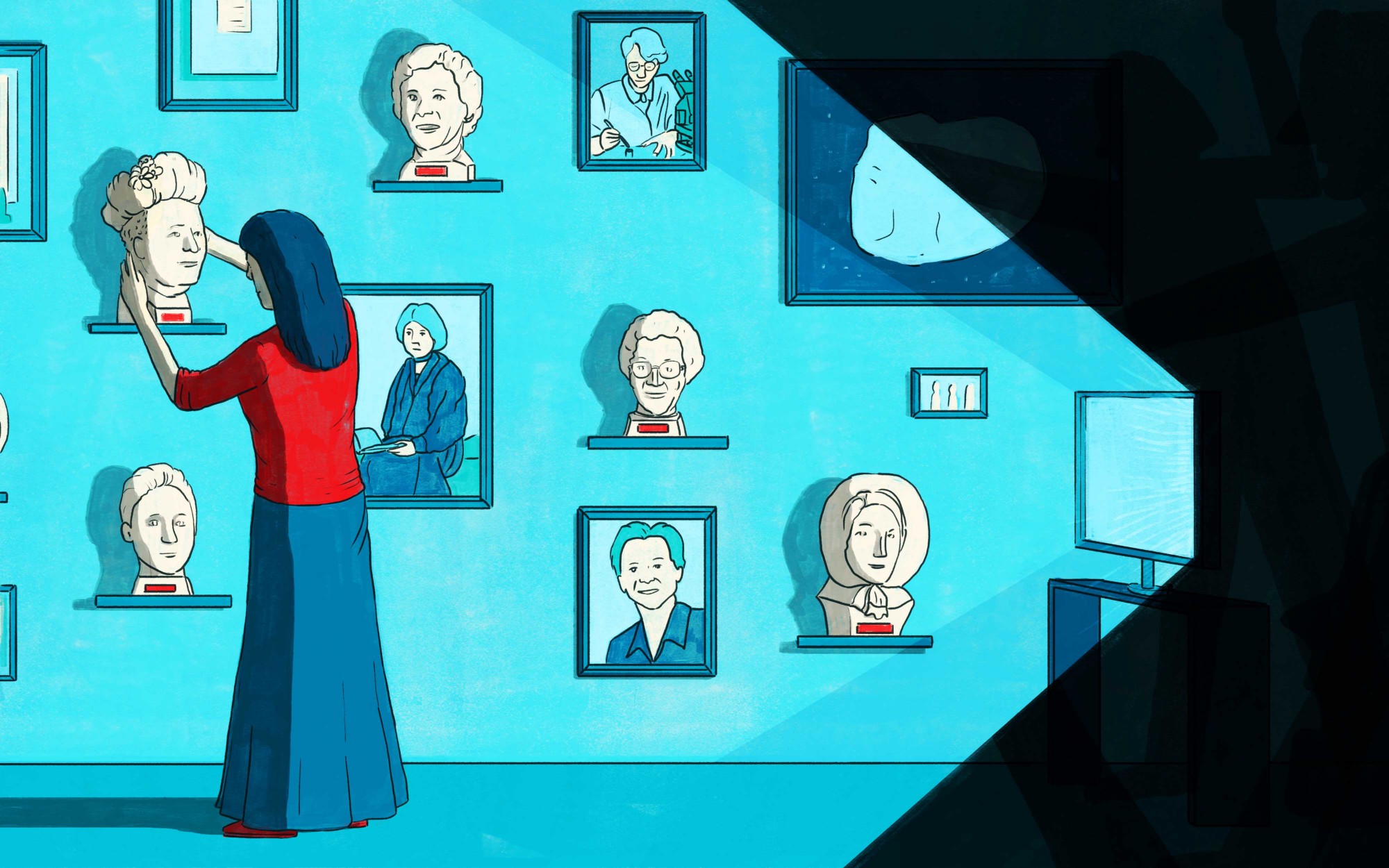Contro Klout
6 min lettura
In un'era in cui se non sei 'social' non esisti, non sorprende l'attenzione di cui gode, ciclicamente, Klout: cosa di più influente di uno strumento che afferma di misurare – con un indice da 0 a 100 – il grado di «influenza» online, rimestando tra retweet, like, menzioni su Wikipedia, descrizioni su LinkedIn e altri circa 400 «segnali» provenienti dallo scintillante universo '2.0'. Il problema, che poi è la fonte principale del suo successo, è che lo abbiamo preso sul serio. E non solo come indicatore – l'ennesimo – del proprio status sociale. Funzione cui, in ogni caso, assolve con sempre maggiore assiduità. Vuoi entrare all'ultimo party alla moda? A Miami, raccontava già l'anno scorso il New York Times, se hai un Klout superiore al 40 hai diritto di accedere a una zona VIP dedicata agli influencer. Vuoi sorseggiare champagne allo show di Malan Breton o festeggiare sui tetti di Manhattan? Dipende dal tuo Klout. E se passate dalle parti del Palms Casino Resort, a Las Vegas, ricordatevi che per voi influentissimi («high-ranking influencers», scriveva Vice nel 2010) c'è un apposito «Klout Klub», un luogo in cui fruire delle infinite amenità del luogo con un servizio degno di essere twittato e ritrasmesso tra tutti i vostri contatti. Un Klout elevato, poi, dà diritto a sconti personalizzati, priorità nei servizi clienti e, presto secondo le intenzioni dell'azienda, nell'assegnazione dei posti in aereo.
Ma l'epidemia da influenza online ha contagiato anche l'istruzione. E, di conseguenza, il mondo del lavoro. Alla Florida State University gli studenti hanno affrontato il primo corso di e-marketing con voto basato interamente sul proprio Klout. «Il punteggio iniziale di 16,7 su Klout all'inizio del progetto», si bea ad agosto 2012 il docente, Todd Bacile, «è cresciuto fino a 39,1 al suo compimento». Risultato discutibile, ma che c'entra il posto di lavoro? «Un miglioramento nel punteggio su Klout aiuterà gli studenti durante il processo di selezione». Altro problema: Bacile ha ragione. La primavera scorsa un candidato a un posto dirigenziale in un'azienda di marketing, un passato in Kraft, Ford, AOL e non solo, si è visto scalzare da un avversario con un Klout più elevato. «Quindici anni di esperienza e risultati non sono stati considerati importanti come quel punteggio», ha detto a Wired. Punteggio che, peraltro, non sapeva di avere, ma aveva. Come per tutti: basta esistere sui social media. Anzi, basta essere esistiti, dato che perfino i morti hanno un Klout. E se non lo si vuole, serve l'opt out direttamente da klout.com. Così è più semplice per chi, come Salesforce.com, intenda inserire tra i desiderata, un Klout di almeno 35 per un posto da community manager. C'è perfino chi ha misurato il Klout dei diversi Stati (vince la Francia con 37,8), trovandoci surreali correlazioni: «i Paesi poveri tendono ad avere punteggi più bassi». Manca solo chi salti su e proponga di aumentare il Klout della Grecia per tirarla fuori dal baratro.
Sordi a decine e decine di articoli critici verso il criterio – pur aggiornato - con cui l'algoritmo assegna un numero alle nostre vite online, alcune recenti analisi su La Repubblica e il Giornale hanno rilanciato Klout anche come termometro dei nuovi centri di potere politico in Rete. Associati, come è facile immaginare per chi quel potere l'abbia ampiamente sottovalutato fino a ieri, agli influencer di Beppe Grillo, del suo 'guru' Gianroberto Casaleggio e del MoVimento 5 Stelle. «Il fortino di Casaleggio vanta il supporto di almeno dieci internauti capaci di un indice Klout superiore a 75», ha scritto Carmelo Lopapa. «Vuol dire che ciascuno di quei dieci "megafoni" è in grado di contattare, influenzare, condizionare almeno 100 mila persone, centomila elettori. Dunque un milione, giusto per capire di che numeri parliamo. E di quanto il virtuale stia acquisendo nel giro di poche settimane peso politico reale, si stia trasformando in consensi e voti». Un errore macroscopico, come spiegano per esempio Piero Tagliapietra e Giovanni Boccia Artieri (in un pezzo datato eppure attualissimo), ma che tuttavia non è nuovo. Già su Vice, infatti, il candidato repubblicano Mitt Romney (all'epoca quotato 84, oggi 90 su 100) veniva accreditato di una capacità di influenza di «448 mila persone». Meno di quelli che il Giornale ha definito i «guru segreti» che «fanno da megafono» a Grillo «influenzando, in questo modo, l'intera Rete»? A quanto pare, sì. Il che dovrebbe darci qualche indizio circa la miseria scientifica dell'indicatore. Oltre che di chi ne parla con una serietà tale da giustificare affermazioni come: «Ecco i grillini più attivi online: così possono spostare i voti degli italiani».
Sì, perché Klout non misura la capacità di influenzare reali decisioni, ma il potenziale di influenzare reali decisioni. Ancora una volta, è l'assunto slacktivista per cui «guidare l'azione» significhi produrre retweet e like e non vere e proprie decisioni di consumo – o di voto – a creare lo sfondo teorico del fallimento. Certo, l'azienda promette di «comprendere come le persone si influenzino l'un l'altra, così che chiunque possa scoprire ed essere riconosciuto per come influenza il mondo». Ma poi, tra le righe, aggiunge che quella «capacità di guidare l'azione» che ne motiva l'esistenza si esplica «sui social network». E il fatto che basti essere retwittati dai top influencer di Twitter per scatenare comportamenti offline per ora resta nella vision di Klout e nelle ipotesi tecno-utopiste di chi ha creduto di abbattere regimi autoritari a colpi di tweet.
Non a caso, da agosto Klout ha fatto autocritica e aggiornato il proprio indice di misurazione cercando di considerare «fonti che indichino influenza nel mondo reale». Prima, infatti, Justin Bieber era più influente di Barack Obama. Ora le parti si sono invertite, perché l'algoritmo considera anche le citazioni e la presenza su Wikipedia. Ma è evidente che manchi ancora tutto: altrimenti si dovrebbe sostenere un riduzionismo wikipediano per cui per conoscere un soggetto – e le relazioni di potere che intrattiene - basterebbe ridurne l'identità ai link alla sua pagina sull'enciclopedia collaborativa. Un processo cui va incontro anche l'analisi del potere: quando si legge che «se tutto va bene, in sei mesi avremo dei nuovi leader» politici grazie alla partecipazione «liquida» in Rete, non ci si discosta dal modello che riduce qualsiasi fenomeno (l'amicizia, la salute, le decisioni di consumo, le preferenze elettorali) alla trama di relazioni che lo identifica nei social network. Salvo poi rendersi conto che ciò che ritenevamo, indice o meno alla mano, particolarmente influente su Facebook finisce travolto da altri – ben più tradizionali – fattori.
Insomma, esistono misure di come l'indice Klout si traduce in comportamenti di acquisto o in reali mutamenti di indirizzo dell'opinione pubblica? No. Però assumiamo lo faccia. Perché? Questo è l'aspetto più inquietante di tanto rumore intorno a quello che, tutto sommato, è uno strumento di marketing come tanti altri (ci sono anche i rivali Kred e PeerIndex). Perché parla di noi, più che del software; del modo in cui ci stiamo consegnando a un algoritmo assolutamente imperfetto, più che della sua imperfezione. E lo stiamo facendo in modo acritico, senza rispondere alla domanda posta da Boccia Artieri, fondamentale: «In che modo la misura dell'influenza ci influenzerà?». Del resto, non interessa nemmeno al fondatore, Joe Fernandez, se cinque anni dopo l'idea del sito può ancora dire a Wired: «Non ho pensato alla componente 'ego' di avere un numero associato al tuo nome».
Eppure bisognerebbe pensarci. Dal punto di vista dei rapporti umani, significa costruire un'ontologia la cui unità di misura fondamentale è l'interazione per l'interazione, più che per il contenuto di quella interazione. Per lievitare su Klout bisogna discriminare (dialogando il più possibile con i soli top influencer), condividere senza sosta (anche a costo di non pensare o pensare di meno) e piacere alla gente che piace (ogni like non vale uno): non esattamente una lezione di civismo. Né, tantomeno, una riedizione del motto content is king, per quanto Klout – ipocritamente – ci provi scrivendo che per ritoccare in alto il punteggio serva «la semplice creazione di buoni contenuti». È infatti la stessa azienda a suggerire il contrario al giornalista di Wired che, partito da quota 31, voglia scalare la vetta degli influencer.
Insieme a quella che Mark Schafer chiama la «democratizzazione dell'influenza», insomma, viene il rischio di incentivare una comunicazione superficiale, mirata tutta ad aumentare non tanto e non solo il numero che ci rappresenta, ma noi stessi attraverso quel numero. Passando così dalla misurazione dell'influenza di una persona alla misurazione di una persona. È lo stesso Klout a suggerirlo quando scrive, tra le domande più frequenti, che no, «non sarete mai penalizzati per esservi connessi o aver interagito con qualcuno con un Klout basso»: grazie, viene da rispondere, per permettermi di parlare con qualche reietto 2.0 senza che mi infetti.
«L'effetto di questi tentativi di quantificazione oggettiva è trasformare i social media da luoghi di conversazione a luoghi di competizione», aggiunge Will Oremus su Slate. Sta già succedendo: basti pensare alla rivolta degli utenti quando Klout ha deciso di rivedere i criteri di valutazione (gli spodestati non hanno potuto sopportarlo), o a quello che Fernandez racconta a Vice: «Specialmente qui, a San Francisco, e quando visito New York, non posso andare a un evento senza che dozzine di persone mi chiedano di aggiustare il loro punteggio su Klout». Eccoti servito l'effetto 'ego', Joe.
Un meccanismo talmente potente da sedurre perfino il co-fondatore di Twitter, Evan Williams. Che ha recentemente dichiarato di stare lavorando a un sistema di misurazione dell'influenza sul servizio di microblogging che vada oltre il semplice numero di follower. Per Jaron Lanier – finito nel girone dei luddisti - ciò significa che «la vita delle persone viene sempre più guidata da algoritmi stupidi». In realtà è peggio: la vita delle persone viene sempre più guidata da idee stupide sul rapporto tra automazione e deliberazione, e da un ego sazio quanto basta per non accorgersene.